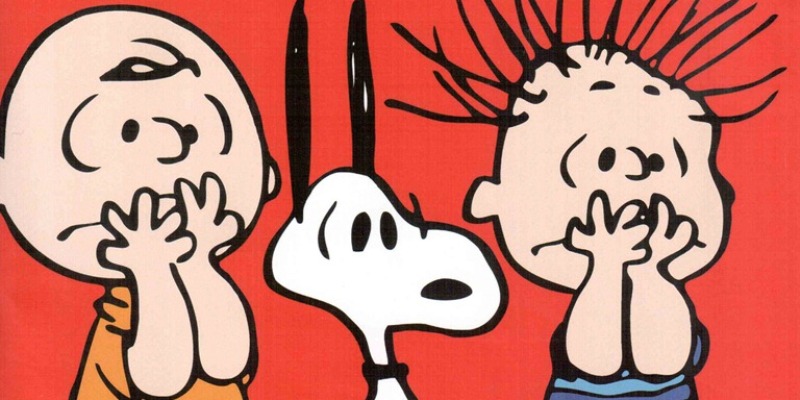Tempo di legge di bilancio, tempo di misurazione delle volontà riformistiche in campo. Il Governo ha presentato un testo preliminare che è commentato nel merito nell’articolo di Benetti. Mi limito a dire che nella sua pochezza di contenuti innovativi ci vedo soltanto la rassegnazione al piacere di essere usciti dalla procedura di sorveglianza da parte di Bruxelles e della riclassificazione in positivo da parte delle Agenzie di Rating. Due risultati alquanto effimeri, perché il problema non è come ci vedono gli altri, ma come ci vediamo noi.
Due indicatori sarebbero sufficienti per togliere il sorriso ai soddisfatti, se avessero standing da statisti. L’Istat ha calcolato che ci sono in Italia 5,7 milioni di poveri assoluti, il 10% della popolazione totale. Per lo più bambini ed immigrati. E’ una cifra che a volerla sgonfiare servirebbe un PNRR ad hoc per molti anni. Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe, bestia nera del governo per la sua documentatissima denuncia dell’agonia della sanità pubblica, la sintetizza così “liste d’attesa fuori controllo, personale stremato e demotivato cha abbandona il Ssn, cittadini che pagano di tasca propria o rinunciano alle cure. Nel 2024, oltre 41 miliardi di euro di spesa privata e 5,8 milioni di persone ha rinunciato alle prestazioni sanitarie” (La Stampa, 14/10/2025).
Il governo non prevede niente sul primo fronte e 6 miliardi per la sanità (2,3 che si aggiungono ai 3,7 previsti dalla passata legge di bilancio) cioè il 15% di quanto occorrerebbe per assorbire il debito di 40 miliardi accumulato finora. Riformismo zero, anche nell’accezione di destra, generalmente tendente alla restaurazione. Il welfare, come valore civico, non è nelle corde della coalizione di governo. Ad essa interessa soprattutto il fisco, ma solo per ridurre le tasse a quello che considera il proprio elettorato. Infatti, ha lavorato alacremente nei primi anni a soddisfare aree sociali e produttive allergiche alle tasse, a renderle un “fai da te”, con la flat tax e sembra che abbia intenzione ancora ora di continuare a sfornare condoni. Non c’è alcuna visione riformatrice seria della politica economica, pur sapendo che procedendo su questo sentiero il baratro della insopportabilità dei divari sociali si avvicina pericolosamente.
Specularmente, le forze dell’opposizione, che almeno keynesiane dovrebbero esserlo, non si attrezzano per riforme corpose sulla politica industriale, sul fisco, sul mercato del lavoro, sulla sanità, sulla formazione dei giovani e meno giovani per affronta la triplice transizione demografica, ambientale e digitale. Anche esse sanno che con i rattoppi ad un tessuto produttivo e sociale logorato da anni di inerzia non si va molto lontano e che occorrono revisioni profonde e adeguate ai cambiamenti in atto. A partire dalla redistribuzione della ricchezza prodotta, che l’attuale sistema fiscale non è in grado di affrontare come Costituzione richiede perché pensato per una società industriale che non c’è più.
Sembra che le forze di sinistra abbiano paura del riformismo, quello che spiega alla gente che la coesione sociale non è un pranzo gratis però neanche una tavolata con i posti occupati da pochi e molti che assolvono al ruolo di servitori. Il riformismo è una strategia di medio e lungo periodo che riassetta i poteri economici, sociali e politici nella direzione di una maggiore solidarietà e uguaglianza. Non può essere una somma di parole d’ordine parziali e settoriali, tipo salario minimo, basta con le liste d’attesa, tassare i ricchi e altre ancora. Dando pure per scontata la loro legittimità, restano una parte di un tutto ignoto ai più. E di questo la gente se ne accorge.
Basti pensare alla questione salariale. Veramente è riconducibile soltanto al salario minimo? Quando tutte le ricerche dicono che mediamente i salari e gli stipendi hanno perso in 10 anni il 16% del loro valore nominale? Non facciamoci illusioni; è un problema più complesso che riguarda, per citare i più importanti capitoli, l’assetto delle imprese sempre più piccole e a bassissima produttività; il fisco che favorisce un paese lillipuziano nella produzione di beni e servizi e l’esenzione per l’80% dei contribuenti dall’essere tassati; la rappresentatività dei soggetti contrattuali per eliminare i contratti pirata; la regolarità dei rinnovi contrattuali la cui mancanza sta creando aree decrescenti di tutele soddisfacenti e aree crescenti di tutele insufficienti.
Il riformismo, nell’area dell’opposizione politica, è soffocato dalla convinzione che è prioritario criticare l’operato del Governo e inseguirlo su tutti i fronti; per avere proposte programmatiche, c’è tempo fino alle prossime elezioni. ll risultato è che l’insoddisfazione verso chi governa non esenta anche chi si oppone e al dunque l’affluenza alle urne scema regolarmente ad ogni tornata elettorale.
D’altra parte, dalle rappresentanze dei corpi intermedi e in particolare da quelle delle forze produttive non giungono pressioni di tipo strutturale. Anche esse si muovono in una chiave congiunturale e per di più in modo sparpagliato. Confindustria e i maggiori sindacati confederali non hanno una comune progettazione di priorità riformistiche. Il Presidente della Confindustria ha puntato i piedi sulla necessità di sostenere gli investimenti; CGIL, CISL e UIL hanno indicato obiettivi diversificati e in comune hanno indicato soltanto la richiesta di detassare gli aumenti contrattuali. E’ vero che una buona fetta dell’aumento delle entrate in questi due ultimi anni sono arrivati dall’aumento dell’occupazione ma soprattutto dagli incrementi contrattuali negoziati dalle parti sociali (di questo il Ministro Giorgetti ha dato atto, sinceramente). E’ quindi ovvio che possa essere forte la tentazione di introdurre una sorta di flat tax anche sui salari, a imitazione dei lavoratori autonomi. Non può essere considerata una innovazione fiscale, ma semplicemente una ritorsione rispetto all’eliminazione del fiscal drag e alla persistenza disparità di trattamento con le altre forme di reddito.
Eppure il riformismo è stato il modo più efficace per modernizzare il Paese, per governare il passaggio dalla società a trazione agricola a quella a trazione industriale. Ora che ci stiamo avviando a passi da gigante verso la società digitale e della comunicazione, bisognerebbe mettere nel conto di attrezzarsi per gestirla senza grossi scossoni. Una ripresa del dialogo sociale e un ritorno al pensare in grande, mettendo in moto le energie intellettuali e scientifiche presenti nella società italiana, rappresenterebbe un messaggio di seria efficacia dell’azione politica. E non sarebbe poco.