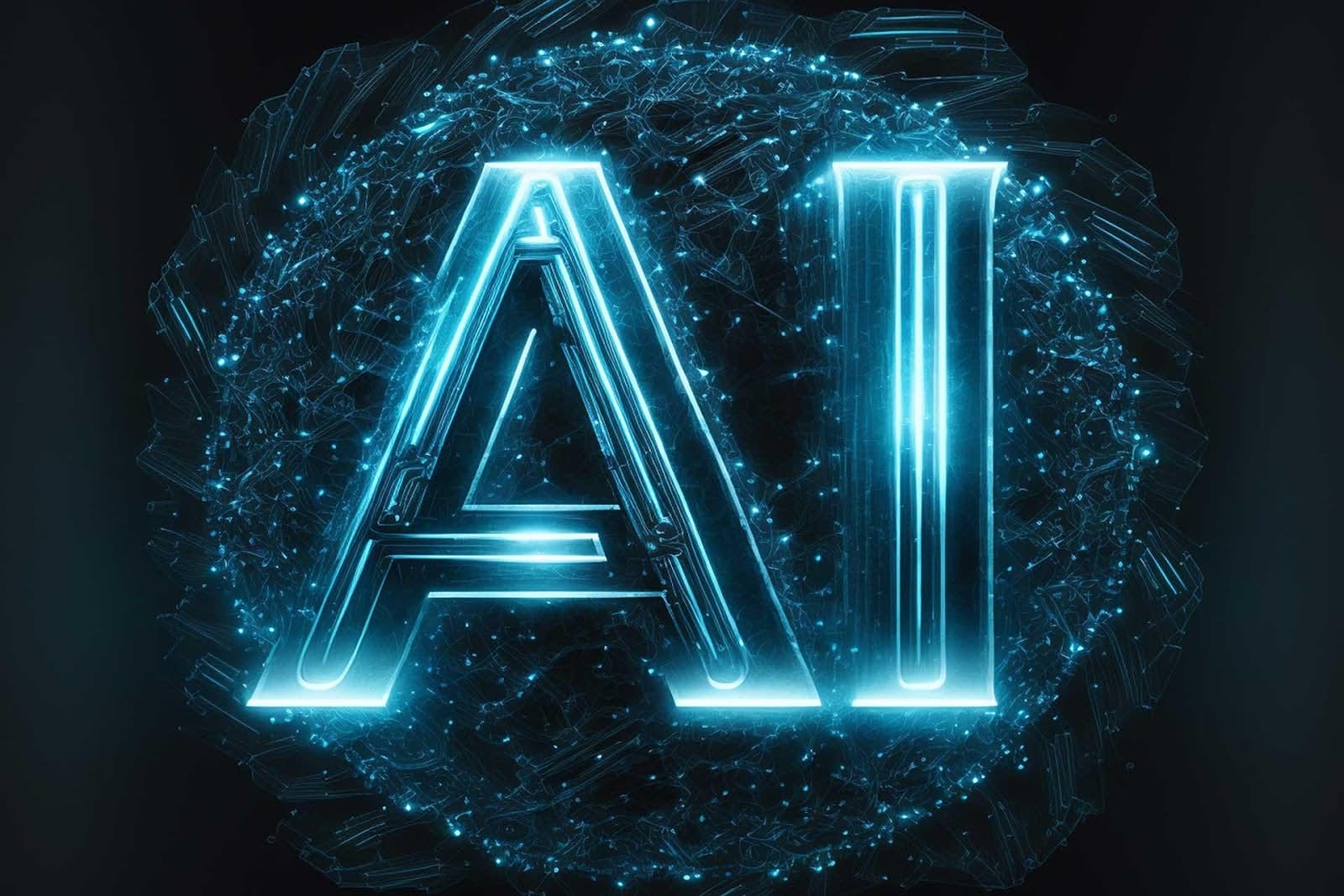Rispetto alle tre grandi transizioni – quella demografica, quella ambientale e quella tecnologica che impattano ciascuna per conto proprio ma anche contemporaneamente, sulle caratteristiche del lavoro – l’Italia è sensibilmente indietro soprattutto sulla terza.
Per quella demografica, ribaltare il processo di denatalità si può, ma si deve agire sui tempi lunghi, mentre nel breve periodo si dovrebbe ricorrere a politiche immigratorie meno ideologizzate e più mirate sia per includere che per riequilibrare il rapporto tra domanda e offerta di lavoro. Per quella ambientale, soprattutto sotto l’impulso europeo, è stato avviato un percorso virtuoso che, sia pure tra alti e bassi (ora siamo in questa fase), sta favorendo una cultura e una prassi finalizzate a preservare la natura, il territorio, le acque, l’aria e anche l’umanità. Molto lavoro c’è ancora da fare, ma non si è all’anno zero, nonostante l’imperversare dei negazionisti.
Stessa cosa non si può dire per la transizione tecnologica. Questione presente in tutto il mondo, man mano che, soprattutto per effetto della diffusione della Intelligenza Artificiale (d’ora in poi AI), produzioni, consumi e conseguentemente qualità e quantità del lavoro mutano profondamente e a ritmo incalzante. L’Organizzazione Internazionale del lavoro prevede che nel 2025 un lavoro su quattro nel mondo sia esposto alla trasformazione generativa dell’AI. Posti di lavoro che spariscono, altri che entrano in campo; professioni che vanno in soffitta, altre che sopravanzano. E non sempre i lavoratori e le lavoratrici dei posti e delle professioni che vengono cancellati sono nelle condizioni di poter svolgere i compiti nuovi e nella misura pari al preesistente.
Inoltre, l’applicazione dell’AI nelle attività produttive, commerciali, educative, comunicative, belliche, di ricerca e finanche artistiche scombina le organizzazioni del lavoro proprie della fase industriale, intervenendo addirittura sul ridisegno delle responsabilità gerarchiche e degli assetti di potere decisionale. Questo è un percorso che non procede per balzi, come avveniva nel periodo dell’automazione dei processi organizzativi. E’ più strisciante ma non meno sconvolgente. Lo sciame innovativo si diluisce nel tempo. Amazon, che ha annunciato un taglio di migliaia di posti di lavoro, non ha affatto garantito che si assesterà sui nuovi livelli occupazionali.
L’età della digitalizzazione e dell’AI non è quella dell’oro, come propaganda Trump, ma sicuramente ci riempirà di meraviglie, di visioni inedite, di speranze positive. Però, come tutte le innovazioni della tecnica dipende da come la si usa. La reazione non può essere luddistica, né catastrofistica. Nello stesso tempo, non si deve neanche lasciarla scorazzare ovunque nelle arterie e pieghe della comunità umana, con effetti al limite del perverso in tutti gli strati sociali. Fa in fretta il ragazzino a convincersi che il sapere scolastico è inutile perchè nel suo smarphone è contenuto tutto il sapere a cui attingere per soddisfare le proprie curiosità e conoscenze e siccome lo sa usare meglio del suo genitore, considerarsi a lui superiore. Al lato opposto, svetta la crescita di tanti Stranamore nel mondo, padroni delle tecnologie delle guerre cibernetiche ma anche delle paci fondate sugli affari e non sul diritto.
Molte sono le questioni che si affollano attorno all’uso corretto dell’AI e non basta limitarsi alla costruzione di un sistema di regole comportamentali e di controllo, come ha incominciato a fare il Parlamento Europeo e la legislazione italiana. A rendere ancora arretrata la consapevolezza del buon governo di questa tecnologia concorrono tre ambiti di intervento.
Il primo riguarda la proprietà delle piattaforme. Queste richiedono consistenti investimenti iniziali ed altrettanti massicci per aggiornarli. Le prime cinque Big Tech del mondo (Amazon, Apple, Google, Microsoft, Nvidia) hanno ormai bilanci che fanno impallidire quelli di tantissimi Stati e conseguono profitti astronomici (nel 2025 si prevedono per i loro azionisti più di 500 miliardi di dollari). L’Europa arranca. Ci vorrebbe un grande patto brussellese tra Commissione Europea, grandi imprese tecnologiche e annesse start up, organizzazioni sindacali per fare massa comune attorno al progetto di autonomia europea sulla produzione e innovazione di AI, di ridisegno dei processi applicativi fino alle medie e piccole imprese e ai servizi pubblici, ad una possente politica di formazione degli adulti, oltre al potenziamento delle lauree nelle tecnologie avanzate.
Non dipendere dai colossi americani deve diventare un imperativo necessitato, come ha ricordato Draghi nel suo Rapporto. D’altra parte, l’Italia agli inizi degli anni 50 del secolo scorso, pur rimanendo amica degli Stati Uniti, non esitò a far nascere l’ENI per non dipendere, in fatto di approvvigionamento energetico, dalle 7 Sorelle petrolifere dell’epoca, tenacemente e duramente oppositrici del disegno italiano. L’Europa deve dotarsi di un apparato adeguato al suo ruolo nel mondo. Esitare significa supina subordinazione.
Il secondo attiene al lavoro. Soprattutto le sue rappresentanze sindacali europee, comprese quelle italiane, sono troppo sulla difensiva, compresse tra la preoccupazione di dover gestire la trasformazione in qualità e quantità del lavoro manuale e professionale e la difficoltà di individuare nuove forme di negoziazione dell’applicazione dell’AI. Soltanto con una grande mobilitazione per contrattualizzare il diritto a conoscere ex ante l’algoritmo che definirà le “n” modifiche dell’organizzazione del lavoro, potrà rendere virtuoso l’utilizzazione dell’AI. Inoltre, la migliore difesa del lavoro, difronte all’innovazione, è di prendere il toro per le corna e definire concreti sostegni sia alla formazione delle nuove competenze, sia alla mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro, per gli adulti. Mai come ora la flexsecurity deve essere un perno delle politiche del lavoro. Finora l’Europa, attraverso il Fondo Nuove Competenze ha dato una risposta soltanto alla questione della riqualificazione dei dipendenti che devono vedersela con l’innovazione tecnologica. Resta scoperto il lato debole del processo: gli esuberi eventuali. E’ previsto nel programma Gol un flebile finanziamento per la formazione degli adulti che perdono il lavoro. Non tutte le Regioni in Italia lo utilizzano. Bisogna trovare il modo per sostenere il reddito di quelle persone che si vedono cancellate le proprie professionalità, che vogliono riqualificarsi frequentando percorsi adeguati in qualità e tempo e risultino tali da accordi sindacali di ristrutturazione tecnologica e ambientale. Prima si affronta in modo strutturale questo problema, prima si assicura un’accelerazione del processo di innovazione e di crescita della produttività.
Il terzo è dato da un approccio minimamente etico a questo uso dell’AI. Una regolamentazione rigorosa a tutela dei minori nel maneggiare il digitale si sta affermando, soprattutto nella scuola. Ma non basta. Ormai è chiaro che si può fare un impiego criminale di ciò che offre o consente lo smartphone, non solo verso i minori ma anche verso le donne e in generale verso chiunque viene individuato come vittima sacrificale. L’anonimato nell’aggressione via social è l’arma principale in questa deriva. Bisogna obbligare a dichiarare chi si è, se si vuole interloquire. Non basta l’autogoverno del fenomeno da parte dei gestori dei social. Arrivano, quando arrivano, sempre ex post e non collaborano con la magistratura e le forze dell’ordine. Si sta distorcendo il concetto di libertà, sconfinando nel liberticidio. E si sta difendendo soltanto la libertà dei colossi del digitale a fare profitti.
L’AI sta dilagando, si piazza come un’ameba sul pensiero, sull’azione, sui comportamenti della società. A volte standardizzandola, a volte collaborando, a volta influenzandola, a volte gratificando la conoscenza e la curiosità delle persone. Ovunque nel mondo. La globalizzazione è la sua dimensione ideale. Spetta a noi, cittadini di questo mondo, esserne i consapevoli e autorevoli orientatori del suo ordinato impiego. In fondo, dovrebbe essere dichiarata bene comune.