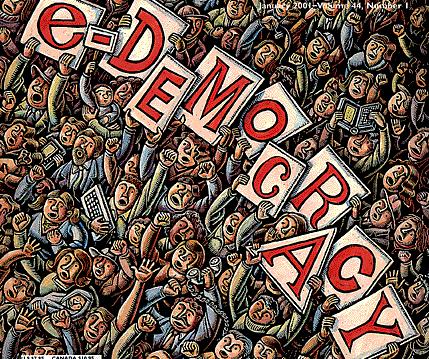Nel 1993 Guido Carli concludeva le sue memorie dedicando al Trattato istitutivo dell’Unione Europea (il Trattato di Maastricht) parole profetiche per il nostro paese. “La classe politica italiana, egli scriveva, non si è resa conto che, approvando il Trattato, si è posta nella condizione di avere accettato un cambiamento di una vastità tale che difficilmente vi sarebbe passata indenne”. Nel 1993 il sistema di partito della Prima Repubblica era ormai imploso e le parole di Carli ne illuminavano le ragioni profonde: vi avevano contribuito non solo la “caduta” del muro di Berlino e la ”rivoluzione dei giudici”, ma soprattutto la nascita di una Unione Europea in cui l’Italia non poteva integrarsi e tantomeno competere restando in balìa di classi dirigenti che governavano con l’espansione incontrollata della spesa pubblica e del debito, con un’inflazione abnorme e le svalutazioni competitive.
Guido Carli era un convinto assertore delle virtù del “vincolo esterno” per disciplinare un paese alla deriva dei corporativismi e di un sistema politico anacronistico da almeno un ventennio. Era stato uno degli artefici dell’inserimento dell’Italia nel Trattato di Maastricht e quindi le sue parole suonano come “una profezia che si autoavvera”, compiaciute e non prive di cinismo. Ma che dire della “classe politica” della Seconda Repubblica? Non intendo inoltrarmi qui in un’analisi così vasta. Ho scelto come incipit quel pensiero di Carli per portare alla superficie il problema storico sotteso alla riforma della Costituzione che viene sottoposta a referendum. In estrema sintesi, si può dire che nella “classe politica” avvicendatasi al governo dopo la fine della Prima Repubblica, il centro-destra ha cercato di eludere il problema delle responsabilità europee dell’Italia mentre il centro-sinistra non è riuscito ad affrontarlo coerentemente. Il problema è se il “vincolo europeo” debba essere necessariamente subìto più o meno passivamente o possa essere gestito con l’iniziativa politica e la forza negoziale di un paese che, “cambiando verso”, acquista voce in capitolo anche per riformare l’Europa dell’ “austerità”, della governance mancata, della crisi di leadership, di missione e di coesione.
Fra questo scenario e il referendum vi è un nesso profondo. La costruzione europea è un mix a geometria variabile di integrazione e competizione fra i paesi membri e non vi si può partecipare chiedendo senza avere le carte in regola per ottenere, oppure subendo perché non si ha la forza per negoziare. Questa forza è la coesione nazionale che solo un governo rappresentativo ed efficace dei cittadini, dello Stato e dell’economia può garantire. Quindi il problema che abbiamo riguarda innanzitutto l’architettura del sistema rappresentativo (la differenziazione virtuosa delle due Camere) e la governabilità: vale a dire la possibilità che il Parlamento e l’esecutivo siano posti nelle condizioni di governare effettivamente il Paese. Il verso delle regole e dell’impalcatura amministrativa che ci siamo dati negli ultimi decenni non è stato questo e, volenti o nolenti, ha generati risultati controproducenti e talvolta disastrosi. La riforma del titolo V della Costituzione approvata nel 2001, lasciando inalterato il “bicameralismo paritario”, ha provocato una proliferazione della legislazione concorrente fra Stato e Regioni che rende quasi impossibile governare il Paese in vista dello sviluppo e della competitività internazionale. Le leggi elettorali che sono state date all’Italia fra il 1993 e il 2006 hanno generato una deriva plebiscitaria che moltiplica la frantumazione politica ed esaspera particolarismi sfrenati.
Naturalmente le degenerazioni denunciate hanno anche altre cause e richiedono rimedi più ampi e arditi di quelli introdotti dalla riforma costituzionale oggetto del referendum. Ma non va sottovalutato il mutamento dell’agenda politica da cui nasce questa riforma. Per dirla alla buona, ci eravamo assuefatti a declinare i nostri problemi considerando il vincolo europeo un destino inesorabile a cui sfuggire con furbizia o da subire passivamente: “ce lo chiede l’Europa!”, “la Commissione europea ha stabilito le compatibilità” e via di questo passo. Andava un po’ meglio quando pareva che il problema fondamentale della politica nazionale fosse quello di “adeguarci” alle direttive europee. Le riforme su cui siamo chiamati a decidere scaturiscono invece da un significativo mutamento di questo modo di pensare. Sono riforme necessarie all’Italia per così dire a prescindere dal vincolo europeo e perciò ci daranno anche più forza e autorevolezza in Europa.
Il ragionamento non è distante, come potrebbe sembrare, dall’esperienza quotidiana dei cittadini che hanno imparato a seguire gli andamenti dello spread con l’ansia di capire se un paese che ha le nostre “incongruenze” e il nostro indebitamento possa risollevarsi e sanno bene che ciò non potrà avvenire se non cambia il modo in cui esso è governato.
L’impalcatura del sistema politico non è fatta solo delle due Camere, delle Regioni e della pubblica amministrazione. Ci sarà molto altro da riformare a cominciare dalla rappresentatività dei sindacati e di altre organizzazioni sociali. Ma il consenso dei cittadini alla riforma costituzionale già approvata dal Parlamento è un primo passo decisivo e indispensabile. Il collegamento con la nuova legge elettorale che non è sottoposta a referendum, è ineludibile e si potrà discutere ancora per migliorarla. Ma il pregio dell’Italicum è nella restituzione ai partiti della responsabilità di organizzare la partecipazione dei cittadini alla elaborazione dell’indirizzo politico del Paese. Il funzionamento dei partiti, la loro coesione, la coerenza democratica dei rapporti fra eletti ed elettori e la trasparenza della vita associativa sono le risorse fondamentali delle democrazie moderne. Le leggi elettorali precedenti l’approvazione dell’Italicum sono state ispirate da una profonda sfiducia nella funzione dei partiti, ne hanno ostacolato la ricostruzione e sono state determinanti nel deformarne la fisiologia. Anche su questo tema, quindi, come per la riforma della Costituzione, si è invertita una tendenza deleteria. Se e quando si dovrà rivedere l’Italicum l’essenziale, per migliorarlo, è non smarrire il criterio che vincola una buona legge elettorale alla ricostruzione della funzione democratica dei partiti.
(*) Giuseppe Vacca Direttore della Fondazione Istituto Gramsci