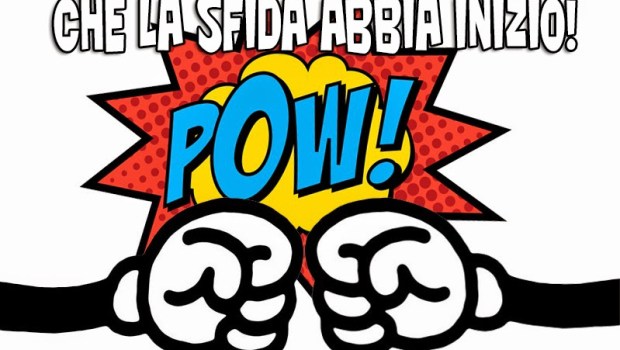Per stabilire se i prossimi mesi saranno amari economicamente e socialmente, non bisogna attendere come si comporterà il “corona virus”(di guai sicuramente ne produrrà se già ora iniziano a scarseggiare i semilavorati per le nostre aziende), che piega prenderà la guerra dei dazi tra USA e Cina (che sembrano stare su una montagna russa), come evolverà o involverà la sorte del Governo italiano (sempre appesa ad un filo). Più importante di tutto questo è tener d’occhio la situazione della Germania, da mesi in difficoltà crescente. Se non si riprende con un colpo di reni ben assestato, significherà che la crisi è sistemica e nient’affatto congiunturale.
Infatti, in Germania ma anche altrove, il cuore delle difficoltà non sta nei consumi individuali ma nella produzione industriale. I primi stagnano perché – a detta di molti analisti – sono in attesa di prodotti nuovi a prezzi accettabili, ripetutamente annunciati. Vale per tutti l’andamento del settore dell’auto, alle prese con un salto tecnologico e ambientalista di portata storica. D’altra parte, l’economia tedesca è parte troppo importante di quella europea e l’interdipendenza è nei fatti, piuttosto che nelle chiacchiere da bar dei sovranisti.
Ma anche se prevalessero le prospettive più ottimistiche, non c’è da illudersi. Siamo nel pieno di una transizione strutturale ed inedita delle economie mondiali e il destinatario più debole è il lavoro, specie in Europa, specie in Italia. Una transizione caratterizzata contemporaneamente da quattro questioni ineludibili che ridisegneranno le prospettive di qualità e di stabilità del lavoro, dei singoli lavoratori, delle loro rappresentanze sindacali.
La prima questione riguarda la globalizzazione. Chi pensa di eliminarla alzando i muri dei dazi, fa danni ma soprattutto spande bugie. Il problema è che veniamo da una globalizzazioneche progressivamente ha cambiato pelle. Se in una prima fase è stata guidata dalla spinta imprenditoriale alla ricerca di nuovi mercati, che ha consentito l’uscita dalla povertà estrema milioni di persone, da un quarto di secolo, è dominata dalla finanza che ha piegato alle sue esigenze rapaci le liberalizzazioni dei mercati, in primis quello del lavoro. Ciò ha creato tensioni sociali crescenti e quindi bisogna operare per una globalizzazione che anteponga la società, la sua coesione al dio denaro. Lo dicono finanche i finanzieri George Soros e Bill Gates. Se si vuol fare qualcosa di concreto, si deve partire dall’eliminazione dei paradisi fiscali esistenti in Europa; da una regolamentazione degli emolumenti dei managers delle grandi aziende per non legarli ai rendimenti alti, immediati e certi desiderati dai capitali investiti; da una dignity of labour tax nei commerci internazionali.
La seconda questione attiene ai mutamenti climatici. Al ritmo attuale degli interventi, si riuscirà a mala pena a fare il solletico all’aggravamento della sostenibilità ambientale della Terra. Ci vogliono decisioni più incisive, più rapide, sostenute dalla piena opzione a favore dell’economia circolare e da investimenti nei settori manifatturieri e dei servizi che riducano drasticamente le emissioni di CO2, possibilmente “prima” del fatidico 2050. Soltanto così il lavoro potrà essere meglio tutelato, governando anche la transizione da un posto ad un altro. Soprattutto il movimento sindacale dovrà farne una priorità di impegno per il presente e per il futuro. Il disinteresse o il mero rinvio preparano l’aggravarsi del panorama attuale (circa 300 aziende in crisi ora sul tavolo del Mise o la tremenda attesa di sapere qual è il destino dell’ILVA) ma anche affannose riconversioni professionali per quote consistenti di lavoratori e nello stesso tempo, ricerca di nuove professionalità carenti nel sistema formativo italiano.
La terza questione tira in ballo l’avanzata delle nuove tecnologie. Sta diventando incalzante, pesa enormemente nella crescita della produttività d’impresa e di sistema. Può essere complementare all’affermazione dell’economia circolare. Nei suoi confronti, né luddismo e né facili entusiasmi. L’intelligenza artificiale non può sovvertire i rapporti tra persona e tecnologia. La prima deve essere sempre prevalente. Ma occorrono tanta competenza, formazione continua, salari decenti, stabilità occupazionale e non il posto fisso perenne, riduzione del tempo di lavoro. E quindi, un rilancio della contrattazione, in chiave partecipativa e preventiva, alle decisioni strategiche aziendali.
L’ultima questione è la più controversa. L’Italia ha molte disponibilità di capitali ma scarseggia di capitalisti disponibili a fare investimenti pazienti, ecosostenibili, innovativi. Non mancano le eccezioni, sono individuabili molte best practices, ma non c’è una diffusione sistemica delle condizioni per favorire capacità imprenditoriali non tradizionali e non di nicchia. Il lavoro potrebbe avere più possibilità di espandersi se intervenissero sia riforme sempre evocate ma mai attuate (in primis giustizia e buona amministrazione centrale e locale), sia nuovi soggetti economici interessati a investimenti non speculativi. Se ne potrebbero individuare di interessanti (molto tempo fa il sindacato, su stimolo della CISL, parlò di introdurre un prelievo dello 0,5% sul salario per alimentare un fondo per investimenti nel Mezzogiorno, ma un inedito asse tra PCI di allora e Confindustria stoppò l’iniziativa). Però, già ora, sarebbe possibile orientare modeste quote dei fondi pensione integrativi verso il potenziamento di attività tecnologicamente avanzate, ecosostenibili e con occupazione stabile.
In definitiva, in questa fase di transizione, il ruolo del lavoratore va visto in una dimensione adeguata alla prospettiva di cambiamento epocale in cui siamo immersi. E’ riduttivo e forse sterile evocare un rinnovato ruolo dello Stato imprenditore (mai come ora, abbiamo letto nostalgiche evocazioni dell’IRI) come unica alternativa alla latitanza dell’imprenditoria privata. Il lavoratore non è un eccetera della società; è uno dei suoi pochi fulcri vitali. Quindi, non basta che ci si impegni per aggiornare continuamente la sua funzione di produttore, per evitare che venga rimandato nell’antica subalternità o nella più recente marginalità. Deve diventare anche protagonista collettivo e determinante di cambiamenti nella politica economica, nella lotta all’inquinamento, nell’umanizzazione dell’economia digitale. Si tratta di dargli una dimensione complessiva e non corporativa o difensiva. Soltanto così può riaffermare con successo la sua dignità nella vita individuale e la sua centralità nelle scelte culturali e politiche di questo Paese.