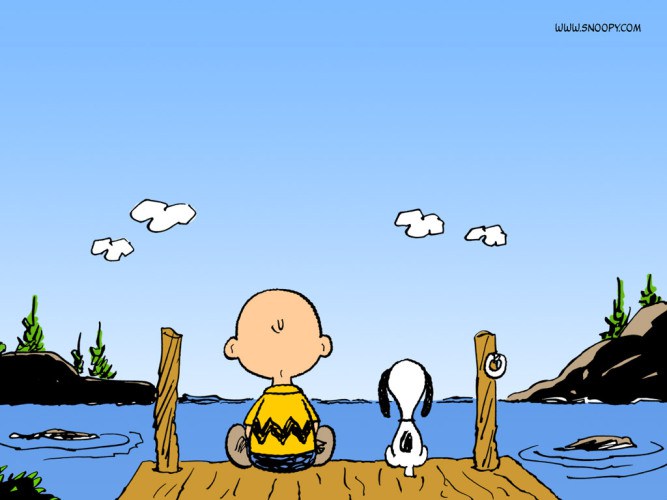Per molte ragioni, il 2016 – anno bisestile, che solleva tante diffidenze tra gli scaramantici – non sarà ricordato come un annus felix. A scala mondiale, basta menzionare l’escalation dei flussi migratori per i quali le risposte dei Paesi ricchi sono state decisamente sconcertanti; l’ondata di estremismo che fa vacillare i livelli di democrazia e la pace nel mondo; la debolezza della crescita economica, inadeguata a sanare le ferite della più lunga crisi che si ricordi. A dimensione europea, spiccano la Brexit e gli svariati muri eretti per soddisfare le paure verso i “diversi”, entrambi campanelli d’allarme per le sorti dell’Unione Europea. E per l’Italia, ci ha pensato il Censis a fornirci una foto decisamente scomposta del tessuto sociale e politico nostrano.
Al pessimismo che tutto ciò induce, fanno da contrappeso, nel nostro Paese, le vicende sindacali. L’anno si conclude con una serie di intese contrattuali e relazionali che non possono passare sotto silenzio. Il protagonismo sindacale ha consentito a milioni di lavoratori di ottenere un contratto rinnovato, scommessa che non molti erano disposti a sottoscrivere. Sia per la forte influenza degli anni precedenti, durante i quali il sindacato si è presentato spesso diviso sui contenuti della propria azione e sulle modalità di intervento e quindi scarsamente influente. Sia per una più apparente che sostanziale egemonia della politica sul sociale, come se le uniche classi dirigenti meritevoli di attenzione fossero quelle che si impegnavano nella destrutturazione delle rappresentanze sociali.
I gruppi dirigenti del sindacalismo confederale non sono rinsaviti di botto. Hanno, però, metabolizzato tanto le esperienze pionieristiche che qua o là si sono evidenziate negli anni della crisi (la vicenda Fiat, il welfare aziendale, l’applicazione negoziale del jobs act), quanto l’inutilità di un’opposizione preconcetta ad ogni cambiamento. In questo, favoriti anche da controparti che, avendo anch’esse problemi di rappresentatività, non si sono arroccate su posizioni radicali (sebbene ci siano state tentazioni forti in tale direzione) ma hanno compartecipato a dare spessore ad una ridefinizione delle relazioni sindacali.
Chi pensa che si tratti di un’espressione di reciproca debolezza o di una fase di tattica congiunturale, sbaglia l’interpretazione di quello che sta avvenendo. Non tutto è limpido, ovviamente; molto è indotto dalle scelte del passato Governo che, complessivamente, sono state “labour oriented”; parecchia strada deve essere percorsa per dare per consolidato ciò che è appena abbozzato. Ma sono le ragioni delle intese che marcano traiettorie non fumose. Ne sottolineo tre.
La lotta alle disuguaglianze emerge come strategia complessa. La redistribuzione della ricchezza non è soltanto faccenda reddituale, ma coinvolge la dimensione del welfare, della formazione, delle tutele minime. E’ un segnale promettente, rivolto tanto ai diretti interessati, quanto all’esterno. Prevale l’idea che non di solo pane vive l’uomo, ma di un benessere che va ridisegnato a misura di rinnovate esigenze, non massificabili ma adattate a situazioni concrete e non generalizzabili. Da qui, la comune valutazione su una netta distinzione tra contrattazione nazionale e quella aziendale o territoriale, tanto nel settore privato che in quello pubblico.
Il bisogno di solidarietà, sia pure nella diversità. Negli ultimi venti anni si sono fatti rinnovi contrattuali, ma l’unico messaggio – in definitiva – è stato nettamente neocorporativo, di pura difesa salariale, ininfluente sulle dinamiche sociali e politiche. In questa tornata, si sente l’eco delle best practices contrattuali a livello aziendale e si delinea la loro generalizzazione a scala nazionale. Tanto nel settore industriale che dei servizi, tanto nelle realtà del lavoro privato che in quello pubblico. Si può obiettare che è ancora poco, che il messaggio verso i giovani è ancora flebile, che la dignità del lavoro si tutela meglio se molta più gente potrà lavorare. Ma non si può negare che il carico di solidarietà espresso non solo è consistente ma parla un linguaggio omogeneo.
Il primato dell’unità sulla identità. I metalmeccanici sono la novità. Erano l’anomalia, che spesso ha contagiato l’insieme delle compagini confederali. Hanno scelto di rompere con le prassi consolidate; di andare oltre il “marciare divisi e colpire uniti” che tanto ha contribuito, nel passato remoto del sindacalismo, a migliorare la condizione dei lavoratori. La sintesi contenutistica del loro rinnovo non è soltanto coraggiosa (in fondo, c’è poco salario diretto e rispetto alle abitudini, una innovazione inedita), ma capace di fare da piattaforma su cui solidificare una visione comune del futuro del lavoro. Questo spiega che si è ben oltre un’idea di unità per necessità. D’altra parte, una generazione di metalmeccanici ha fatto da apripista per l’unità negli anni 60 e seguenti. Un’altra ha preso atto, nella notte di S. Valentino del 1983, che i tempi non erano maturi per l’unità organica. Spetta a quella attuale di risperimentare la prospettiva unitaria per sé e per il resto del sindacato.
Tutto ciò affonda la sua solidità nella consapevolezza che il lavoro sta cambiando profondamente, sia nel privato che nel pubblico. C’è aria di Industria 4.0 dappertutto, dalla fabbrica robotizzata massicciamente, al capannone dell’artigiano, dagli ospedali ingegnerizzati alle scuole informatizzate. Cambieranno orari, mansioni, criteri di organizzazione e di valutazione, modalità di coinvolgimento. Ovunque. E’ questo che riempirà di novità l’impegno del sindacato futuro prossimo.
Intanto, buon Natale e buon anno a tutti.