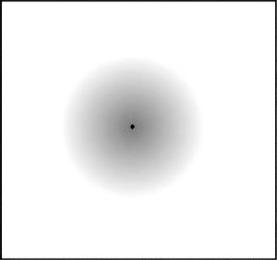Uno degli argomenti a sostegno della richiesta della CGIL di referendum abrogativo sui vouchers è che la struttura produttiva italiana è troppo frammentata, più facilmente tentata di usarli per sfuggire ai costi e ai vincoli di altre forme di contratto di lavoro, meno controllabile sia dalle istituzioni pubbliche che dal sindacato. Tutto vero. Ma allora il problema non sono i vouchers. Se venissero aboliti, c’è da scommettere che non si guadagnerebbero molti posti di lavoro stabile in più. Il film è già stato visto. I vouchers sono strumento di recente invenzione in Italia. Pochi anni fa, dilagava il lavoro nero, appena attenuato dal lavoro accessorio. Si stava meglio, quando si stava peggio?
Il guaio è che la voglia di esagerare è vizio antico. Già si sapeva – quando nell’ambito del jobs act l’utilizzo dei vouchers fu esteso a tutti i settori – che ci sarebbero stati abusi. Eppure allora, ci fu tanta disattenzione e furono in pochi (Nuovi Lavori tra questi) a sollevare obiezioni. Ora si vorrebbe esagerare in senso opposto. E’ sperabile che la saggezza guidi la penna del legislatore e riconduca in alvei più ristretti, controllabili e sanzionabili, il ricorso a questo strumento di “flessibilità buona”, come avviene in tanti altri paesi europei. Se poi quello che verrà deciso potrà evitare il referendum, è unicamente questione della Corte di Cassazione.
Resta in piedi tutta la problematica della struttura delle imprese italiane. Troppo piccole, troppo deboli, troppo precarie. Per di più, senza essere ancellari ad una struttura consistente di medie e grandi imprese nostrane, che con la lunga crisi iniziata nel 2008 ha subito smottamenti significativi. Inoltre, la loro esposizione alle turbolenze del mercato è stata traumatica e resa più sofferente da un sistema bancario che invece di aiutarle a capitalizzarsi, quando le vacche erano grasse, ha preferito riempirle di prestiti, salvo poi strozzarle a crisi inoltrata. “Piccolo è bello” fu slogan felice, negli anni settanta e ottanta. Fotografava una fase di vitalità del sistema produttivo italiano finanche esportabile. Ma non regge più.
Un po’ meno piccolo sarebbe più bello, verrebbe da dire. Siamo ancora la seconda potenza industriale europea e se vogliamo rimanerci e affrontare l’avvento dell’economia della conoscenza con le carte in regola, dobbiamo porci il problema di avere alcuni “pivot” produttivi competitivi con altri presenti nell’economia globalizzata, ma soprattutto di avere un sistema di piccole e medie imprese capace di competere in maniera sana. Se no, la tentazione di scaricare tutto sui risparmi normativi e salariali del costo del lavoro resterà sempre incombente.
Per essere all’altezza dei tempi, le piccole e medie imprese devono puntare ad avere alcune condizioni di base. Innanzitutto, più capitalizzazione propria. Deve dipendere sempre meno dal credito bancario e sempre di più dalla robustezza della propria patrimonializzazione. Se questa esigenza ha un senso, bisogna rivedere buona parte della legislazione di sostegno fiscale e contributivo alle imprese. In particolare, quella per le start up, in cui poco peso hanno il valore dell’investimento immateriale che si intende sviluppare e la qualità dell’occupazione che essa induce.
In secondo luogo, occorre favorire un management non improvvisato. Da esso dipende il tasso di efficienza organizzativa dell’impresa, la sua capacità di espansione nei mercati, le possibilità di visioni di medio e lungo periodo. E’ un mestiere che ha bisogno di forte e costante allenamento e che non sempre è coltivato nelle imprese familiari, per cui una crescente separazione tra proprietà e gestione andrebbe favorita soprattutto nelle aziende medie e piccole che sono in campo da tempo.
Infine, più occupazione diretta e stabile. Le statistiche sulla ripresa debole ma costante dell’occupazione indicano che le imprese stanno attingendo dal serbatoio dei cinquantenni in su, a spese dei giovani. Si fa rientrare al lavoro chi ha competenza e esperienza. Probabilmente, chi da garanzie di maggiore fidelizzazione. Il fenomeno è interessante perché è indice di un contestuale salto di qualità del modo di lavorare. Meno routiniero, più qualificato. Se le piccole e medie imprese si irrobustissero sotto l’aspetto patrimoniale e manageriale, accrescerebbero anche l’occupazione stabile, in questo modo ricorrendo anche al serbatoio dei più giovani.
Tutte le politiche di incentivazione pubblica andrebbe calibrate su queste direttrici, con interventi strutturali e non temporanei, mirati e non estemporanei, attenti alla qualità del fare piuttosto che alla quantità dei beni dati in garanzia. Basterebbe un’agenda di obiettivi di breve e medio periodo per sollecitare un impegno collettivo dei singoli, dei corpi intermedi e delle istituzioni pubbliche per dare senso al futuro e qualche sicurezza in più a chi ne ha bisogno.