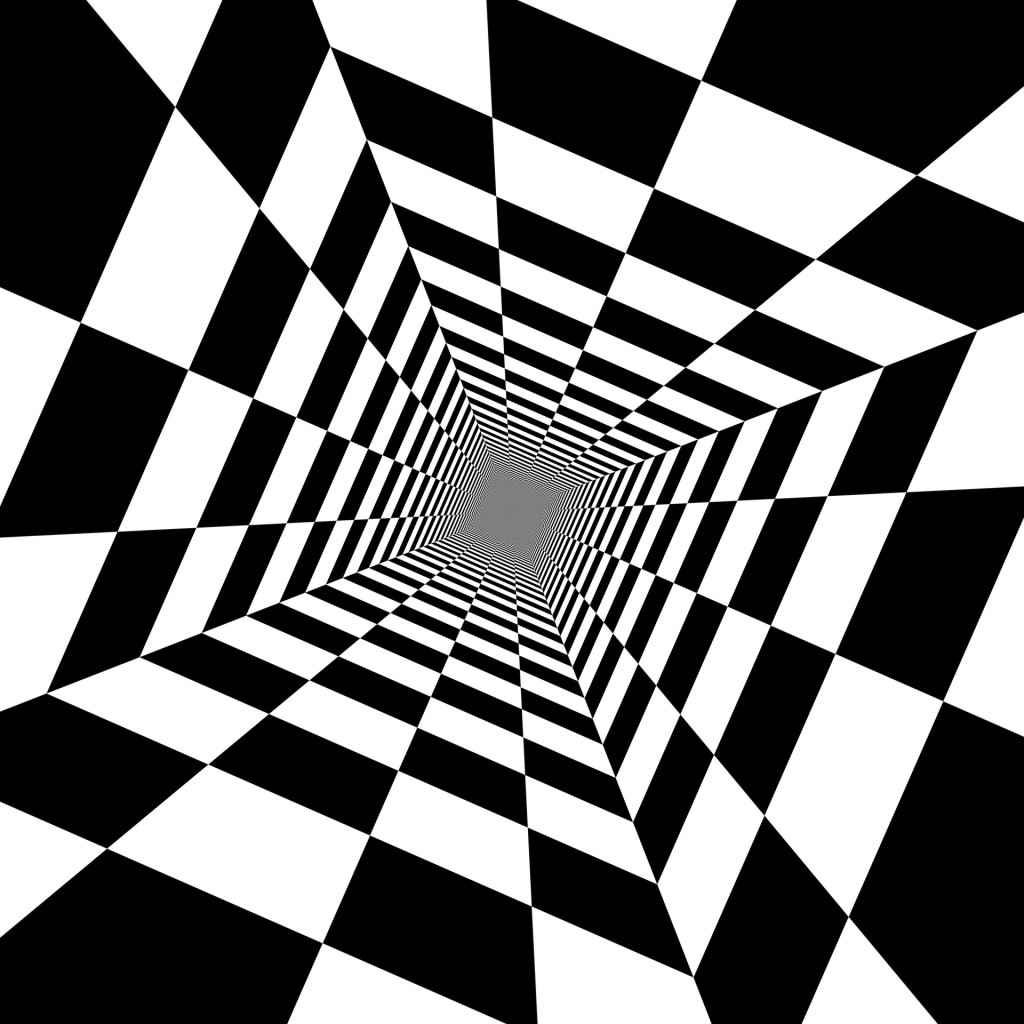Nel corso dell’ultima legislatura è spirato un vento contrario alle grandi organizzazioni di rappresentanza degli interessi. Dopo una iniziale sordina (governo Letta) la parte centrale della premiership di Renzi è stata dedicata allo sganciamento dal condizionamento di questi attori dentro l’arena politica.
In questa sede cercheremo di capire se questa prospettiva fosse dotato di fondamento e se essa abbia prodotto risultati apprezzabili, approfittando così anche per discutere del destino di questi soggetti.
Dunque lo stile decisionale scelto dal governo nel periodo 2014-16 si è ispirato alla messa in discussione non solo della concertazione (gli accordi tra governi e parti sociali) ma più radicalmente del diritto stesso d’accesso di queste organizzazioni alla sfera politica. Alle origini troviamo la manifestazione di una diffusa insofferenza sociale verso il ruolo politico dei cosiddetti corpi intermedi: quel che ruolo aveva fatto parlare nel nostro Paese di ‘sindacato soggetto politico’. Una insofferenza raccolta già dal governo Monti (2011-13), che aveva attaccato la concertazione definendola obsoleta. In quel caso si era trattato di uno sviluppo in qualche modo naturale di posizioni classicamente liberaldemocratiche, reinterpretate e adattate. Il filone, a cui si è più chiaramente ispirato questo nuovo ciclo politico, si fonda invece sulla contrapposizione delle virtù della democrazia ‘immediata’ ai difetti della democrazia ‘intermediata’, costruita appunto intorno al ruolo attivo delle associazioni di rappresentanza. Infatti la parola d’ordine di questa stagione è stata condensata nella espressione, in realtà abbastanza inquietante, della ‘disintermediazione’
Questa posizione presenta ascendenze, più o meno lontane, con gli ideali di una democrazia diretta, di derivazione Rousseauiana, con la quale condivide anche alcune analogie nei difetti. Anche in passato questo filone che immagina una appropriazione diretta delle decisioni da parte dei diretti interessati – produttori o cittadini – ha evocato tanto suggestioni che tentativi di messa in opera. Così è stato per la democrazia consiliare all’interno del movimento sindacale, che trova ancora qualche epigono nelle organizzazioni minoritarie che si richiamano meccanicamente alla ‘democrazia di base’.
La traduzione contemporanea trova il suo propellente nelle grandi potenzialità dell’innovazione tecnologica, e dunque dell’uso della rete in chiave di democrazia diffusa. Questo infatti è l’esplicito richiamo che si rintraccia nelle prassi del Movimento 5 stelle, cioè il soggetto politico che ha provato a costruire la sua identità, almeno in parte, su questa leva.
La democrazia immediata, dentro questo approccio, presenta il vantaggio evidente non solo di coinvolgere maggiormente le persone, ma anche quello di superare le lentezze e le distorsioni attribuibili al processo di intermediazione decisionale (specie in una realtà ad alto pluralismo associativo, come quella italiana).
Nella realtà possiamo nutrire diverse perplessità intorno al funzionamento e alla stessa qualità democratica dei vari disegni o applicazioni derivate dall’ideale della democrazia diretta. Così è avvenuto in passato nella sfera sindacale, anche in presenza di forme di partecipazione e di militanza diffuse, che si traducevano comunque in maggiori opportunità solo per pochi: minoranze più o meno consistenti.
Sul piano concettuale anche l’attuale filone suscita diverse obiezioni. Da un lato esso si traduce in una sorta di nuova passivizzazione delle persone, stimolate all’inseguimento del potere miracolistico della democrazia del click. Da un altro lato esso si risolve, come ricordato da Nadia Urbinati, in una sorta di ‘democrazia giudicante’, che semplifica tutto intorno ad un si o un no, uno schema che non comporta impegno e costi informativi.
Ma al di là degli aspetti concettuali, pure rilevanti, quali sono state le manifestazioni più significative nella scorsa legislatura di queste suggestioni e quali esiti hanno prodotto?
Gli anni passati hanno sicuramente visto un intenso sforzo legislativo, e sono stati segnati da un rafforzato interventismo pubblico nella sfera del lavoro. Uno sforzo caratterizzato da gradi diversi di declinazione della cosiddetta disintermediazione.
Il più dirompente e discutibile è consistito nella famosa erogazione di 80 euro ai lavoratori a basso reddito, scavalcando le tradizionali regole della sovranità contrattuale delle parti sociali in materia salariale. E’ la modalità che potremmo definire dell’‘interventismo sostitutivo’.
Una seconda modalità è quella materializzatasi nella proposta e realizzazione del Jobs act, il quale è stato l’impegno più importante, anche sul piano simbolico, nel cuore della legislatura. Una elaborazione e un percorso legislativo che si sono realizzati in modo conclamato all’insegna del fare a meno del contributo degli attori sociali al fine di marcare la autosufficienza decisionale del governo e il primato della politica. E’ quello che potremmo considerare come un “interventismo per decreto “ (parafrasando una categoria analitica suggerita in passato da Michele Salvati).
Una terza variante è consistita nell’approccio più morbido dell’incentivazione economica verso comportamenti virtuosi degli attori, adottata ad esempio mediante misure costruite per favorire la contrattazione decentrata, ed in particolare quella orientata a migliorare la produttività delle imprese. Si tratta di una variante più vicina alla logica promozionale dei classici interventi di sostegno al lavoro e ai sindacati, che potremmo quindi definire come ‘interventismo di accompagnamento’.
Come è noto nel corso del 2016, ed ancora più a seguito del risultato negativo del referendum costituzionale, è stata messa in campo una dinamica delle relazioni sociali – dei rapporti tra istituzioni pubbliche e attori collettivi – più simile a quella del passato. Tale da produrre alcune intese rilevanti, come in materia di pubblico impiego (Accordo – quadro del 30 novembre 2016, Accordo in materia di riassetto di alcune regole pensionistiche). Questo riavvicinamento non ha sin qui prodotto esiti spettacolari, o spettacolarmente pubblicizzati, di ampia portata generale e simbolica. Piuttosto ha dato luogo ad una sorta di ‘concertazione implicita’, che segna principalmente un mutato – e più disteso – clima tra i tre attori (considerando anche le articolazioni dell’esecutivo come ‘terza parte’).
Se leggiamo le forme che hanno prevalso possiamo considerare la fase centrale della legislatura come il tentativo di realizzare una sorta di governo pro-labor, ma senza ricorrere al tradizionale raccordo con i soggetti del lavoro organizzato. In passato questo raccordo era parso – anche in sede scientifica – come necessario proprio al fine di migliorare i risultati e il consenso per il governo pro-labor: questa era la logica a cui si ispirava la lettura concettuale dello ‘scambio politico ’, proposto da Pizzorno circa un quarantennio fa. In questo slittamento di paradigma il presupposto era invece, all’opposto, che faceva bene tanto al consenso che agli esiti la capacità di decidere senza il sindacato (e l’insieme delle parti sociali).
Sembra di poter rilevare che questo calcolo non abbia trovato conferma nei risultati acquisiti, nonostante la loro ambizione iniziale avrebbe meritato sorte migliore. In sostanza il disegno riformatore alla fine è risultato ambivalente o zoppo, anche perché ha sottovalutato l’apporto che le parti avrebbero potuto dare al suo miglioramento. In particolare nella fase di impostazione, in modo da garantire un buon bilanciamento tra i diversi interessi sul tappeto, e poi in quella di implementazione, in modo da favorire impatti più efficaci e socialmente più equilibrati. In altri termini dentro un disegno, che si nutriva esplicitamente del riferimento a modelli di flexicurity, proprio la maggiore inclusione dei sindacati, magari ben dosata, avrebbe potuto assicurare una più chiara incarnazione della gamba indispensabile della stabilità e della protezione sociale.
Più in generale bisogna considerare che l’assunzione troppo schematica della prospettiva della disintermediazione presenta alcuni vantaggi potenziali, ma anche rischi da non sottovalutare. Da un lato infatti essa allude ad una maggiore libertà di manovra nelle decisioni e ad una maggiore latitudine (virtuale) di consensi sociali. Da un altro lato se viene portata alle sue conseguenze essa può condurre alla delegittimazione degli stessi attori della politica, che si caratterizzano anch’essi a loro volta come soggetti di mediazione. E dunque risolversi nella semplice riedizione di un quadro di decisioni gerarchiche e verticali: esattamente quelle che nel corso del novecento i sindacati avevano contestato in ragione della loro ristrettezza.
Ma queste considerazioni critiche verso la regolazione politica – nel nostro Paese ancora chiaramente alla ricerca di una parte in commedia – non assolvono i limiti e i ritardi delle parti sociali. Esse sono apparse nostalgiche di un copione che non è più proponibile. E sono entrambe in larga parte risultate indietro rispetto all’esigenza di un reale rinnovamento e di una sintonia significativa con le domande di cambiamento che vengono dal nostro sistema produttivo e dal mondo del lavoro. Si è dunque registrata la carenza da parte loro di quella capacità di proposta di cui avrebbero beneficiato in termini qualitativi le decisioni nell’arena della regolazione del lavoro. Un tema fondamentale ed ancora irrisolto, dopo averne tanto parlato, resta infatti quello della rappresentanza sindacale. Un tema che più che mai sembrava maturo: oggetto di un buon accordo (ma non realizzato praticamente) tra Confindustria e Confederazioni sindacali, segnato da una crescente condivisione della necessità di un intervento legislativo, infine caratterizzato dalla disponibilità assunta sin da subito dal governo a dare corpo per legge a questa materia. Eppure alla fine nessun esito è stato raggiunto: il segnale di una impotenza che una migliore cooperazione tra i tre attori avrebbe potuto condurre ad una riforma davvero importante per le relazioni industriali italiane.
In breve sintesi possiamo dunque parlare, a dispetto di alcune premesse positive, di una legislatura che, nonostante alcune evoluzioni non disprezzabili, come ad esempio quelle in materia di politiche attive del lavoro e di contrasto alla povertà, si sia alla fine tradotta in una occasione perduta proprio in ragione della mancata sintesi tra soggetti pubblici e attori collettivi. Una legislatura che lascia in eredità alla prossima il nodo inevaso di quali siano i criteri più adeguati per costruire tra istituzioni e attori sociali un ponte ben definito e reciprocamente accettabile, ma anche più fortemente orientato in chiave realizzativa.