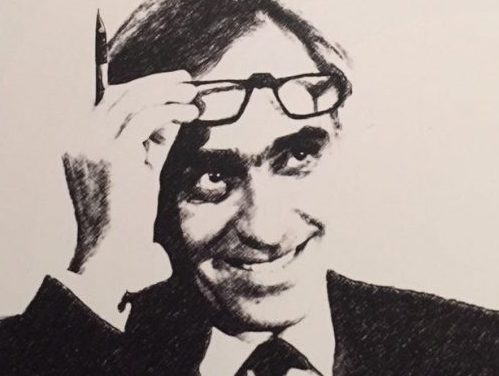Mi sarebbe stato più facile parlare di Carniti, ancora in vita. I sentimenti di profonda amicizia, l’intensità della frequentazione fraterna, la carica di umanità e rispetto reciproci interferiscono con la volontà di guardare al suo “detto” e al suo “fatto” con distacco. Quasi tutti gli interventi raccolti in questa parziale rassegna di opinioni e testimonianze riflettono lo stesso disagio. Ma per me, gioca a sfavore un senso di inadeguatezza che, tra l’altro, è stata la ragione per cui finora non ho espresso alcun pubblico cordoglio. Di conseguenza, chiedo venia, in anticipo, per ciò che scriverò, per l’incompletezza che l’accompagna.
Per iniziare, ci tengo a dire che Carniti non è stato un marziano sceso nell’agone della seconda parte del novecento per sconquassare visioni consolidate del ruolo (subalterno) dei lavoratori, nel pieno del passaggio dell’Italia da società rurale a società industriale. Non c’è titanismo nel suo modo di pensare ed agire. Certo, pensava in grande, sempre. E agiva in modo coerente. Ma la corrispondenza con la realtà, sia del pensiero che dell’azione, era nei fatti. Certo, quel pensiero lungo e profondo e quell’agire con energia e tempestivamente lo rendevano fastidioso a chi non riusciva a guardare oltre la punta del proprio naso. Il conflitto sociale era nelle cose, in quegli anni sessanta e settanta. Lui aveva la capacità di vederlo prima degli altri e di sistematizzarlo – con la collaborazione di uno stuolo di giovani pensatori, diventati tutti noti negli anni successivi – in modo da trasformare il conflitto in un nuovo equilibrio.
Assieme a Trentin e a Benvenuto ha saputo dare un senso all’azione sindacale sempre riformista nei contenuti e partecipativo nelle modalità. Il corporativismo era lontano mille miglia dalla sua cultura cattolica progressista e un po’ anche filo-americana. Anche le lotte più aspre di quel ventennio, così tumultuoso, furono canalizzate verso soluzioni che soddisfacevano l’esigenza di coinvolgere sempre i lavoratori nelle decisioni e nello stesso tempo caratterizzavano in chiave innovativa ma non eversiva la condizione di lavoro nelle aziende piccole e grandi.
Emblematiche furono le numerose battaglie condotte per eliminare il cottimo. Per trasformare l’operaio da soggetto che “vendeva” il suo tempo a protagonista che “contrattava” il suo fare. Soltanto un padronato ottuso e poco aperto a ciò che succedeva nel mondo poteva non accorgersi che il cottimo era un arnese coercitivo in via di estinzione. Bastava fare un salto in Germania per rendersi conto di quanto fosse anacronistica la sua resistenza. Eppure occorsero centinaia di ore di sciopero per convincere le singole aziende a cambiare. Con il sindacato impegnato non solo contro quella forma di sfruttamento, ma a favore di soluzioni capaci di accrescere la produttività, senza forzare sull’”olio di gomito”, come in gergo si diceva allora.
Nella visione di Carniti, il conflitto non è mai stato fine a sé stesso. Gli estremisti di allora, per questa ragione, non lo amavano. Lo scontro sociale doveva servire per far stare meglio i lavoratori sul piano salariale e professionale, ma anche per irrobustire il senso di dignità e per alzare progressivamente la loro potenzialità civica e politica. Dal conflitto a scala aziendale o per il rinnovo contrattuale doveva sempre emergere una proposta d’interlocuzione con la società. La partecipazione riguardava gli interessi in quanto subordinati, ma doveva esprimere anche valori che si rivolgessero alla realtà sociale. Soltanto in questa logica si può comprendere la scelta della FLM di fare nel 1972 una grandiosa manifestazione dei metalmeccanici a Reggio Calabria, nel pieno della rivolta neofascista del “boia chi molla” (quella volta ebbi veramente paura della incolumità di Carniti).
L’egualitarismo, attraverso gli aumenti salariali uguali per tutti, il solidarismo, attraverso la riduzione dell’orario di lavoro, travalicavano lo specifico contrattuale e parlavano a tutti. Gli anni settanta e ottanta furono quelli in cui l’indice di Gini – quello universalmente utilizzato per misurare le disuguaglianze – segnalarono una riduzione dei divari reddituali nel nostro Paese. E questo anche e soprattutto per l’azione sindacale sia in fatto di welfare che di fiscalità, oltre che di contrattualismo diffuso. Valori come l’egualitarismo e il solidarismo non si alimentano mai da soli, né soltanto dal basso. Senza un’azione dirigente, assidua e tenace, non si possono affermare. E le disuguaglianze che si sono accumulate nelle società a capitalismo maturo, in questo inizio di secolo, sono anche conseguenza dell’affievolimento dell’incidenza di questi valori e dell’appannamento dell’impegno leaderistico del sindacato.
Carniti intuì che lo sbocco del conflittualismo non poteva essere una delega in bianco al sistema dei partiti ed in particolare al PCI in merito alle esigenze sociali complessive. Lo Stato non doveva essere soltanto espressione del sistema dei partiti, ma doveva configurarsi, di volta in volta, come il risultato di una dialettica più complessa che riguardasse anche il sindacato, in quanto espressione autonoma e diretta di donne e uomini consapevoli di assolvere un ruolo “generale”. Il suo primo tentativo di dare corpo a questa dialettica fu la proposta, passata alla storia sindacale, come “lo 0,50”: l’accantonamento del prelievo di mezzo punto del salario individuale per alimentare un Fondo destinato agli investimenti nel Mezzogiorno. Si era all’inizio della grande recessione della fine del secolo scorso. Si incominciava a parlare di “sacrifici”. Carniti non si sottraeva a questa prova di responsabilità, ma la coniugava in una logica di scambio. Manco a dirlo. Si opposero contemporaneamente la Confindustria e il PCI, la prima perché vedeva in quella proposta la nascita di un insidioso protagonista nei processi di accumulazione capitalistica, il secondo perché considerava le questioni di ordine generale una propria esclusiva.
Il capo della Cisl non era abituato a lamentarsi. Mise in campo, rapidamente, un’alternativa, la sua terapia d’urto contro la stagflation, lanciando la “concertazione” tra Governo e parti sociali, per aggredire le ragioni strutturali della crisi e introdurre gli anticorpi per ripartire con lo sviluppo. In questa cornice si collocava la proposta di contenimento della dinamica della scala mobile. Nonostante le incomprensioni, dentro (fu finanche tacciato di “neocorporativismo”) e fuori (soprattutto dalle forze politiche di sinistra) il sindacato – grazie anche all’autorevolezza di Tarantelli, economista veramente pro-labour, ucciso per questo dalle Brigate Rosse – si fecero le prime prove di questa centralità del contributo dei lavoratori per risollevare un Paese allo stremo. E’ storia nota.
Il PCI indisse un referendum sulla scala mobile che perse soprattutto al Nord; però, riuscì a frantumare l’unità sindacale in modo profondo e con essa ogni prospettiva di “concertazione” come modello di governo della complessità non solo nell’emergenza ma anche nella normalità. Non c’è concertazione senza l’unità delle confederazioni più rappresentative. Non c’è confederalità vera senza ruolo di rappresentanza generale. E non c’è rinnovamento della politica senza un sistematico confronto tra istituzioni, partiti e corpi intermedi.
In questo periodo, si moltiplicano le riflessioni sulla crisi della politica. Basta pensare al libro di Damilano (Un atomo di verità, Feltrinelli) e a quello di Vacca (L’Italia contesa, Marsilio) che datano al 1978 la fine della politica con la P maiuscola, in Italia. A mio parere, a tenerla in vita – sia pure a fatica – poteva contribuire la “concertazione”, ma non fu compresa la gravità della malattia della politica e quindi non apprezzata la cura proposta. Come al solito, Carniti capì questo intreccio essenziale prima di chiunque altro. Lo argomenta con eleganza nel lungo racconto che fa nel libro che gli abbiamo dedicato in occasione dei suoi ottanta anni (AA.VV. Pensiero, azione, autonomia, Edizioni Lavoro). E con la pena nel cuore, ma con la lucidità della ragione, lasciò la Cisl e la militanza attiva.
Chi, come me, ebbe in sorte di proseguire sul suo solco, sperimentò le mille difficoltà nel fare, giorno dopo giorno, il sindacato partecipativo dopo la frattura unitaria. Le ricomposizioni successive erano troppo segnate dalle disillusioni, i gruppi dirigenti sindacali continuarono a stimarsi, fecero anche cose rilevanti (accordo del 1992/93), ma non riuscirono a far decollare l’aereo appesantito da un trascorso doloroso e troppo recente. Una intera generazione di sindacalisti era stata marchiata dalla doccia scozzese della unità/disunità. In seguito, il ripiegamento verso l’unità d’azione è stato troppo caratterizzato più dalle convenienze e dagli opportunismi congiunturali che da scelte strategiche impegnative; il primato dell’ identità divenne ben presto prevalente sul primato della ricomposizione dell’ alleanza tra lavoratori stabili, i precari e i disoccupati.
Forse Carniti sarebbe molto incuriosito dalla fase che si sta aprendo nel nostro Paese che è di rottura di continuità con il passato economico, sociale e politico. Le ragioni di inquietudine e di preoccupazioni che ogni giorno si rafforzano, preludono a cambiamenti profondi. Sarà importante quello che riusciranno a proporre, in questi mesi a venire, prima ancora dei partiti, la società civile, i corpi intermedi per non far arretrare ulteriormente i valori di uguaglianza e solidarietà che stavano tanto a cuore a Carniti. In particolare, sarà interessante vedere se l’attuale e soprattutto l’emergente nuova generazione di sindacalisti nelle tre confederazioni, quella che non era in prima linea allora ma ora e per l’immediato futuro è l’ossatura portante del movimento sindacale abbiano l’ambizione di proporre un progetto di coesione sociale all’altezza dei tempi, rifuggendo dall’inevitabile ripiegamento corporativo. Come lui, come tanti altri, starò a scrutare l’orizzonte più ravvicinato possibile, sperando e credendo che il sindacato molto può fare per un destino dell’Italia e del’Europa migliore di quello che si intravede.