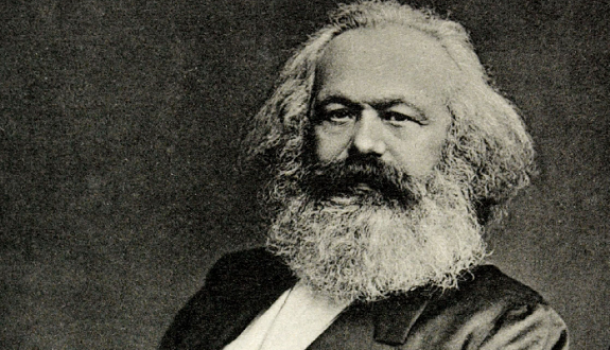Marx è stato il mio imprinting giovanile e, più che Marx, la produzione di vari autori marxisti (o non marxisti, ma che comunque a lui si riferivano). Il bagaglio si era confusamente già definito quando la mia formazione si è indirizzata verso l’economia, consolidandosi soprattutto a Cambridge (negli anni d’oro della Faculty of Economics) e, in Italia, nell’Istituto (si chiamavano così i Dipartimenti) diretto da Sylos Labini, quindi in un universo intellettualmente laico. Avere alle spalle quel piccolo bagaglio marxiano è stato importante poiché da subito ha contribuito a farmi guardare l’economia da un punto di vista sociologico, nella consapevolezza che dietro le relazioni stilizzate vi è la struttura della società. Oggi – dopo tanti anni (nei quali c’è in mezzo il confronto continuo sul tema negli anni Settanta con Salvati, Vianello, Ginzburg, Lippi e tanti altri in quella fucina di idee che era allora la Facoltà di Economia di Modena) e dopo tutte le maturazioni (passatemi il termine) che ha avuto la mia riflessione intellettuale – che cosa rimane di Marx? Qual è il consuntivo di insegnamenti che il confronto con la realtà e con la disciplina è andato distillando dentro di me e che mi sentirei di proporre come guida a un giovane che si avvicini oggi a lui? Quali considerazioni ci stimola anche nelle parti della sua produzione che ci appaiono più lontane dall’evoluzione del mondo corrente?
Il centro dell’analisi
Ovviamente, in ciò che segue, il Marx che presento è come io l’ho sistemato nella mia mente ed è un Marx riferito al bagaglio analitico che ci ha trasmesso. Il Marx che si proietta in un finalismo storico non l’ho mai considerato rilevante e, sotto sotto, è anche una forzatura inerpretativa. Il filosofo, lo storico, l’economista, il sociologo, l’umanista che in ciascun campo dà il «là» a un modo originale di vedere le cose è, invece, di grande rilievo. Quel «là» vorrei affrontarlo da scienziato sociale nel profilo specifico. Non senza difficoltà e umiltà di fronte a una produzione vastissima (fra l’altro in parte non pubblicata in vita) sia perché fatta di appunti, sia perché dell’assetto e delle affermazioni
contenute Marx non era evidentemente convinto fino in fondo (penso fosse così anche per il Secondo e il Terzo libro de Il Capitale, che furono poi editi da Engels, quelli, per intendersi, che contengono gli schemi di riproduzione).
Marx è soprattutto interessato ad analizzare la realtà a lui contemporanea, quella del capitalismo industriale (delle fabbriche) e a darne un quadro complessivo. Ha due interessi che si rintracciano in tutta la sua opera: uno è di mettere in evidenza la struttura interna di una società forgiata dal capitalismo e, in un certo senso, offrirne la fotografia; l’altro è di capire i meccanismi di funzionamento di quel modo di produzione, le direzioni in cui si muove; indagarne quindi le sequenze dinamiche che esso ha insite.
Sono due interessi fecondi, ma distinti, da cui scaturiscono indicazioni importanti, che hanno, però, necessità di una premessa. La risposta che Marx dà seguendo questi due filoni non ha a mio avviso, per entrambi, la necessità della teoria del valore-lavoro. Non è questa una stella polare, il principio originario da cui discende tutto l’impianto; né Marx muore o sta in piedi con la validità di quella teoria. Sebbene sia la parte che più ha affascinato gli studiosi e sulla quale si sono spesi fiumi di inchiostro, il suo accantonamento non provoca danni al valore scientifico dell’indagine che Marx porta avanti. È un livello alto di astrazione e anche di azzardo. Chiunque voglia metterlo al centro dell’impianto rischia di indebolirne la solidità. Che orientamento ci dà, oggi, il valore-lavoro quando sappiamo che un iPad assembla pezzi provenienti da 40 Paesi e incorpora tanta conoscenza e varia di prezzo con i tassi di cambio? O che i salari («il lavoro vivo») rappresentano il 7% nel costo diretto di un’automobile? Quello che ci basta ritenere è che la distribuzione del reddito è conflittuale, dipende dai rapporti di forza, che il profitto è un residuo nel valore delle merci dopo che sono stati pagati i lavoratori e i beni intermedi. Se proprio si vuole, ci si può riferire a Sraffa, che queste proposizioni ha convalidato, operando sugli schemi di riproduzione, sia pure allo stesso livello alto di astrazione nella formazione dei prezzi.
Da Marx estraiamo, però, l’idea che il valore intrinseco dei beni è il prodotto di un insieme storicamente specifico di relazioni sociali e che lo scambio che avviene sul mercato, apparentemente tra equivalenti, nasconde uno scambio tra diseguali. Lo sfruttamento («il pluslavoro, o eccesso di lavoro vivo, appropriato dai capitalisti») rimane come categoria sociologica e termine evocativo di un rapporto sociale, ma occorre rinunciare a fondarlo «scientificamente».
La fotografia del capitalismo
Detto questo, ci sono orizzonti analitici e insegnamenti che rimangono tutti interi e hanno informato generazioni di studiosi in vari campi. Hanno costituito svolte nel pensiero e rimangono come fondamenti della scienza sociale, ancora oggi illuminanti.
Se rimaniamo nell’indagine fotografica, in primo luogo direi che Marx ci ha instradato a capire che l’economia definisce la struttura fonda- mentale della società, cioè il sistema delle relazioni sociali e politiche. Queste sono inerentemente conflittuali e antagonistiche perché il capitalismo produce interessi contrapposti. Marx poi li rappresenta attraverso una società polarizzata tra capitalisti e lavoratori, che sappiamo non è stata l’evoluzione effettiva della società, anche se quella contrapposizione non è mai scomparsa. Qualsiasi cosa sia successa, l’insegnamento analitico non ne è inficiato e la verità contenuta in quel modo di indagare la società rimane feconda. Dopo Marx, studiare i processi sociali significa interrogare le cause economiche che li producono e quale sia il meccanismo che ne deriva.
Il materialismo storico è altrettanto un insegnamento metodologico ri- masto totalmente integro: la storia è fatta da individui le cui condizioni materiali e la cui posizione nell’ordinamento sociale sono dati ereditati, ma che essi stessi sono in grado di cambiare nel loro agire, come protagonisti del conflitto insito in quelle configurazioni.
Per quanto concerne il suo insegnamento sull’alienazione, esso è talmente entrato nell’armamentario filosofico e sociologico da esimermi dall’andare oltre.
Un altro importante insegnamento che ci ha lasciato e che ci guida tutt’oggi è che il capitalismo non è solo un processo di produzione materiale, ma è anche un processo di produzione culturale: l’humus culturale e il mondo antropologico (inteso come modo di guardare le cose, interpretare le relazioni di causa-effetto, introiettare i valori ecc.) che si afferma si forma in conformità alle visioni del mondo dei poteri dominanti. Quell’universo culturale tende a legittimare l’esistente come un ordine naturale privo di alternative e a far apparire come interpretazione scontata e universale ciò che è ideologia. Anche l’ordinamento giuridico rientra nello stesso ambito di interpretazione e non è mai neutro.
In relazione a questi caratteri della società, Marx ci insegna che il compito dell’intellettuale è esercitare una critica sociale e politica e svelare la sostanza dei rapporti sociali nascosti dietro le categorie sociologiche, economiche e filosofiche della scienza veicolata dai poteri dominanti. Solo l’analisi scientifica della realtà fa giustizia di tutte le ideologie da essi costruite. Ma non si ferma qui: spetta all’intellettuale provare le possibilità di un salto qualitativo.
Nel quadro generale del sistema capitalistico, Marx ci dice anche che la produzione aggregata deriva da un coacervo di rapporti di scambio e interconnessioni tra settori produttivi e che il suo assorbimento è in rapporto col reddito che si forma all’interno di quel processo. Gli schemi di riproduzione, al di là di essere fondati sul valore-lavoro, abituano a ragionare con questo panorama ampio del processo complessivo; la fotografia macroeconomica che disegnano aiuta a capire quali siano, in un equilibrio astratto, le condizioni di produzione e riproduzione che connettono tra loro i singoli settori. Ne fa un punto di partenza, poi, per affrontare la tematica delle crisi.
Sequenze dinamiche del capitalismo
Altrettanto e forse più importanti sono le proposizioni legate all’inqua- dramento «cinetico» del capitalismo. Per Marx, il capitalismo ha una forza dinamica interna legata alla sua logica, che è logica concorrenziale e che spinge alla continua accumulazione del capitale. Il profitto ne è la molla e la condizione. Questa forma di produzione è intrinsecamente proiettata ad accrescere le forze produttive e le possibilità materiali, perché non può vivere senza rivoluzionare continuamente i processi di produzione e, di conseguenza, senza sviluppare la tecnica. Marx, che è teorico del capitalismo, è anche in un certo senso affascinato dalla carica dinamica e di progresso che sprigiona.
In questo continuo dinamismo, la forza distruttrice e creatrice della concorrenza sviluppa una tendenza a concentrare la proprietà dei mezzi di produzione, convogliando al tempo stesso potere di mercato e ricchezza in un gruppo sociale ristretto (oggi non lo riferiremmo più all’allargamento delle unità tecniche di produzione ma alla centralizzazione di un complesso di attività tecniche in pochi centri di comando tra loro coordinati).
L’accumulazione di capitale non è, però, un processo lineare e indolore, perché incorpora una gamma di contraddizioni interne, a partire dal fatto che la generazione del profitto ha bisogno di un esercito industriale di riserva che tenga bassi i salari e dal fatto che quelle condizioni astratte di equilibrio macroeconomico, di cui sopra, raramente (seppure) si danno. La tendenza allo sviluppo diseguale caratterizza tutte le relazioni economiche e sociali. Per cui il capitalismo va studiato in condizioni di continuo disequilibrio. È instabile e genera conflitti, alcuni dei quali sfociano in recessioni periodiche quando non in vere e proprie crisi. Il capitalismo non si riequilibra da solo.
Su come le crisi avvengano per Marx si dovrebbe aprire un capitolo a parte, ma essendo il mio intento valutativo e non ricostruttivo, mi limito a tre battute di sintesi sulle modalità che egli intravede. Oggi diremmo che hanno tutte luogo dalla caduta degli investimenti che segue a una caduta dei profitti o della profittabilità. L’incalzare di una crisi può derivare dall’assottigliamento dell’esercito industriale di riserva (Marx anticipa quella che chiamiamo oggi curva di Phillips), o da una caduta tendenziale e strutturale del tasso di profitto (la modalità più debole), o, ancora, dalla difficoltà di realizzazione dei profitti, dovuta alla sovrapproduzione in alcuni settori che si diffonde in tutta l’economia (essenzialmente la causa prima della crisi del ’29). Per tutte, Marx vede delle controtendenze; tutte portano all’intensificazione della concorrenza, del progresso tecnico e accentuano le tendenze alla concentrazione. Aprono sempre condizioni per riprodursi.
Più che seguirlo sulle dinamiche delle crisi, occorre soffermarsi su due importantissimi insegnamenti – analitici e metodologici assieme – presenti nel ragionamento di Marx e intrinseci a una visione dinamica dell’economia. Potremmo entrambi considerarli una pietra miliare di una impostazione alternativa a quella dell’economia dominante, detta neo-classica (che, infatti, è prevalentemente statica). Ma sono insegnamenti che anche molti economisti non appartenenti al versante main- stream trovano ostici da seguire.
Nella rappresentazione dei processi dell’economia poco o nulla può essere parametrato in relazioni deterministiche. L’astrazione più consona all’economista è di estrarre le catene causali stabilite dalle forze dominanti in gioco (e dalle logiche endogene) e riflettere sulla portata relativa di spinte e controspinte (e circostanze collaterali) che fanno prevalere alcune di queste forze sulle altre e che dall’interno possono cambiare anche la direzione del movimento. Si tratta quindi di mettere in sequenza logica catene non molto lunghe di relazioni di causa- effetto che catturino i punti di trazione (o di frizione o squilibrio) e riducano l’analisi a un nucleo di proposizioni semplificate e compatte, nonché solide sul piano concettuale e fattuale. È ciò che Marx fa e da cui l’economia mainstream è lontana mille miglia. Seguire interdipendenze generali, come fa l’economia dominante, serve solo a offuscare le gerarchie dei processi; pretendere di far muovere le relazioni meccanicisticamente (sino alle conseguenze ultime di un equilibrio finale) fa perdere di vista che non vi è nulla di lineare o meccanico nella dinamica economica e sociale e che il materiale con cui trattano gli economisti non è costante, omogeneo o stabile, ma muta con le forze della produzione e le influenza a sua volta.
Il secondo insegnamento è altrettanto importante ed è ancora più tra- scurato del primo, ed è che dall’interazione degli attori nascono forze e si determinano esiti che non corrispondono al volere consapevole di nessuno e finiscono per essere condizionanti per tutti. Marx parla delle «forze coercitive esterne». Per lui la concorrenza lo è. È creata dall’agire capitalistico, ma alla fine si impossessa dei capitalisti e li costringe ad accumulare. Marx ci dice, in sostanza, che le dinamiche endogene sono altrettanto importanti dell’agire strategico e che è un errore personifica- re alcuni esiti riconducendoli al volere di qualche agente collettivo. Vi è sempre in mezzo un mercato impersonale e anarchico, imprevedibile nei suoi sviluppi, nel quale le decisioni di attori diversi che agiscono con le loro logiche confliggono (o anche trovano coordinamento). Molti esiti possono semplicemente essere stati utilizzati, più che pianificati. Per capirci, come possiamo classificare, se non come «forza coercitiva esterna», che si erge all’interno di varie contraddizioni, lo sviluppo del mercato dell’eurodollaro – nato dalle dinamiche di allora –, alla cui forza condizionante si deve la caduta del sistema di Bretton Woods? Similmente, cogliamo quanto sia importante questo insegnamento di Marx se pensiamo a quanto i governi occidentali abbiano visto negli indirizzi di mercato e competitivi una via di uscita per la crescita, per poi diventare prigionieri di quel Prometeo che hanno sbrigliato e che ha stretto in una morsa la loro libertà di politica economica.
Marx ci rinvia a processi non lineari di trasformazione. Contrariamente al modo in cui il suo pensiero viene correntemente interpretato, questa indeterminatezza è quanto va estratto di più fecondo. Va estratto questo, e non che esista un destino già scritto nella storia umana. Sappiamo solo che c’è un conflitto tra lo sviluppo delle forze produttive e la composizione sociale, ma il resto è anarchia del mercato (controllata o meno). È vero, però, che egli vede il capitalismo come transeunte e destinato da questa anarchia a sfociare in una società socialista. Ma è solo una congettura, un’ipotesi, non una legge ineluttabile. Prendiamola per quella che è. È come se, partendo da un’analisi approfondita, seria e rigorosa della natura e struttura della Lega e dei 5 Stelle, ci mettessimo a prevedere quale possa essere la durata del governo di coalizione. È una congettura che lascia il tempo che trova; quello che rimane è la profondità dell’analisi che non cade certo se le congetture avanzate si rivelano sbagliate.
Soggettività e azione consapevole
Qui sta un punto importante. La rottura (in special modo quella rivozionaria) non avviene per ineluttabili condizioni oggettive che la rendono inevitabile. Accanto alla valorizzazione del capitale, Marx guarda alla produzione di soggettività ed è consapevole che l’elemento decisivo nella nascita della nuova formazione sociale è l’intervento soggettivo. Nulla avviene per sviluppi naturali. Attribuire a Marx l’assenza di una dimensione della soggettività o affermare che tutto sia riconducibile a forze oggettive non è corretto. È un giudizio nato con lo sviluppo della psicologia e dell’importanza che oggi diamo all’individualità. E penso che egli avrebbe obiettato che le tante determinazioni e identità che pure muovono i comportamenti individuali sono comunque in relazione (inconsapevole) con le condizioni materiali (e come tali, infatti, vengono studiate oggi da molta scienza sociale). La sua preoccupazione è la coscienza di classe, ma non la dà per scontata: è un’acquisizione personale nel rapporto con la realtà. Egli parla di classe in sé (che è un dato di fatto, esiste sociologicamente) e classe per sé (i singoli che formano una coscienza convergente, si riconoscono nei propri simili, e diventano classe che agisce come soggetto per modificare il proprio destino: che è un dato da conquistare). Parla genericamente di «proletariato» ma conosce la fabbrica; sa che il tornitore non è naturalmente portato a considerare il suo destino legato a quello dell’elettricista che gli lavora accanto. Anche se la fabbrica educa al lavoro associato e co- operativo, il formarsi di una coscienza di classe che consenta di riferirsi al «proletariato» o alla «classe operaia» come soggetto consapevole di sé (e quindi come soggetto politico) è una costruzione – appunto – politica.
Quello che non è chiaro è se in Marx la formazione della coscienza di classe debba essere portata dall’esterno o debba venire dall’interno, nell’esperienza quotidiana di costruzione di legami e strumenti di autodifesa e di riconoscimento. È un dibattito che in altri tempi ha appassionato il nascente movimento operaio. Ma, se dovessi interpretare il suo pensiero, direi che è piuttosto una coscienza che viene dall’esterno, da un disvelamento pedagogico, dal lavoro di educazione, mobilitazione e rappresentazione della posizione che ciascuno occupa nella società in relazione agli altri. È un lavoro, in definitiva, mirato all’acquisizione della consapevolezza dell’antagonismo per consentire a ciascuno di riportare la propria condizione sociale ai meccanismi di appropriazione e di funzionamento del capitalismo. L’identità collettiva si forma, poi, dentro un progetto collettivo.
Oggi sappiamo bene che se i processi culturali sono lasciati a sé stessi e se si è soli nel giudizio sulla società si è facilmente preda dell’ideologia e della visione del mondo veicolata dalla classe dominante, oppure del ribellismo, della protesta distruttiva (jacquerie) o, com’è ora, dell’antipolitica (oppure ce la si prende col gruppo che sta sotto). Oggi la cultura dominante – a parte la legittimazione degli esiti del processo capitalistico – propone valori che fanno leva sull’individuo e tende a dimostrare che il proprio destino dipende unicamente da sé stessi.
Che cos’è cambiato nel capitalismo in generale
Detto questo, che cosa è cambiato nel capitalismo dal tempo di Marx e che cosa non ha visto dell’evoluzione sociale o non ha potuto vedere o prevedere? Oggi, in estrema sintesi, non potremmo parlare del capitalismo senza far riferimento a due attori: lo Stato e la finanza. Il primo introduce una responsabilità pubblica sugli assetti produttivi e sociali, diventa veicolo di integrazione della società e consente alle classi subalterne di influire sulle decisioni. La seconda introduce logiche particolari e alimenta «una forza coercitiva esterna» su tutti gli aspetti del processo capitalistico. Quando è forte un attore è debole l’altro, e viceversa. A seconda della relativa forza abbiamo due tipi di capitalismo. Il primo è caratterizzato da processi che culminano con il governo delle socialdemocrazie tradizionali; il secondo da processi che sostituiscono la trazione finanziaria a quella produttiva e forgiano una società regolata essenzialmente dal mercato.
È diversa oggi anche l’organizzazione della produzione. Non avrebbe sorpreso Marx che essa si svolga in un quadro di proiezione internazionale che egli aveva intuito come intrinseca a quel modo di produzione, pur essendo morto alla fine dell’Ottocento, dunque solo agli albori della più grande libertà mai avutasi nel mercato aperto. Oggi l’unità tecnica di produzione si è ridotta, e sono più rari i grandi assembramenti operai. Non vi è stata concentrazione ma centralizzazione, concessa da tecnologie che consentono di governare attraverso la Rete, e con la massima flessibilità, le singole funzioni che portano al prodotto finale. Decentramento, esternalizzazioni e terziarizzazione hanno disperso la forza lavoro nei Paesi a capitalismo avanzato e posto in concorrenza parti diverse della classe operaia mondiale. La produzione manuale richiede sempre meno lavoratori, i quali sono sempre meno sindacalizzabili: la distribuzione diseguale del reddito e della ricchezza è sempre più pronunciata tra chi ha le leve della produzione e della finanza e chi ne dipende come lavoratore.
Ma questi cambiamenti, per quanto importanti, non contraddicono né la fotografia che Marx fa del capitalismo, né il quadro cinetico che egli ne dà. Rimangono quadri sottostanti, pur se con tinte più fioche (lo Stato) o più accese (la finanza).
Il ruolo dello Stato
Sul modo in cui il ruolo dello Stato sia cambiato rispetto a Marx è bene fermarsi. Marx non vede (e forse non poteva vedere) la forza propulsiva (direi anche ideale) della democrazia e la possibilità di far valere in essa la rappresentanza e le istanze delle classi subalterne. La definisce «un involucro giuridico borghese» e non vede le potenzialità nella rivendicazione del suffragio universale e del rapporto tra conquiste della democrazia e socialismo.
Questa possibilità è colta, invece, dalla socialdemocrazia tradizionale che individua nel processo rappresentativo le potenzialità che si aprono sul terreno giuridico-istituzionale di far valere i rapporti di forza e piegare il capitalismo a una logica socializzante. Essa vede la possibilità di utilizzare lo Stato per politiche pubbliche, per presidiare con la legge i comportamenti economici e per controbilanciare il potere che si crea sul mercato, facendo esprimere il conflitto di classe attraverso la politica organizzata.
In fin dei conti, la socialdemocrazia condivide molte delle conclusioni di Marx: il capitalismo genera instabilità e crisi; produce una sproporzionata diseguaglianza di potere, ricchezza, forza sociale e condizioni di vita; è soggetto ai fallimenti del mercato; genera insicurezza sociale e interessi contrapposti che trovano soluzione nella legge del più forte. Ma ritiene che questi caratteri possano essere portati sotto controllo o attenuati con i poteri dello Stato.
Marx, tuttavia, non è del tutto estraneo a questa impostazione. È vero che afferma che lo Stato è una sovrastruttura creata e riprodotta in conformità all’affermarsi di un certo modo di produzione, ma è poi attraverso lo Stato e i suoi indirizzi che dovrebbero realizzarsi quelle misure che (con Engels) poneva nel Manifesto del 1848 come base di superamento delle logiche del capitalismo («che appariranno insufficienti e insostenibili, ma indispensabili per rivoluzionare il modo di produzione capitalistico […] e che nel corso del movimento supereranno sé stesse»).
Si tratta dell’espropriazione della rendita fondiaria, dell’imposta progressiva, della limitazione del diritto ereditario, dell’istituzione di «fabbriche nazionali», dell’istruzione gratuita, di una sorta di esercito del lavoro, dell’abolizione del lavoro minorile e altre. Non solo queste misure sono state largamente realizzate, ma spesso si è andati oltre quel programma che gli autori del Manifesto giudicavano radicale. Rinvio al bell’articolo di Massimo Florio per un’analisi puntuale (Stato e socialismo: rileggendo una pagina de «il Manifesto», «Democrazia e Diritto», n. 4/2016). Il capitalismo nella sua evoluzione storica è andato oltre sé stesso nell’incorporare principi di socialità e di responsabilità collettiva. Oggi sono sotto la responsabilità statale i servizi sanitari, la redistribuzione, le pensioni, la casa, la ricerca, il sostegno agli investimenti privati e tanto altro. Si è diffusa una cultura della responsabilità pubblica sugli assetti della macroeconomia e della vita sociale. La spesa pubblica è aumentata in 150 anni (dal 1870, cioè da pochi anni prima che Marx morisse) di quattro volte rispetto alla crescita del Pil e (la mia fonte è ancora Florio) da una proporzione del 18% è arrivata a una media del 45% nei Paesi capitalistici industrializzati (con un ritmo di crescita che non si differenzia tra i Paesi che sono stati guidati dalle socialdemocrazie e quelli che non l’hanno avuta come forza politica).
Nella logica socializzante del processo produttivo hanno potuto inserirsi la politica organizzata e la rappresentanza dei ceti subalterni per realizzare di volta in volta conquiste che approfondivano quella logica, sfruttando le possibilità esistenti sul terreno giuridico istituzionale e create dal mutamento dei rapporti di forza. Nel conflitto che si è aperto con la logica del profitto tesa a restringere e bloccare le spinte socializzanti, la politica organizzata ha potuto prevalere per un lungo periodo. Le conseguenze di questo sviluppo dello Stato e anche i caratteri che esso ha assunto quando è stata la logica della politica a prevalere su quella del profitto e del mercato ci illuminano molto nel capire perché Marx non abbia avuto ragione nelle sue congetture sul futuro del capitalismo. In sintesi, lo sviluppo dei sindacati e il mutamento dei rapporti di forza hanno consentito che i frutti della crescita produttiva si distribuissero anche ai lavoratori: i salari sono cresciuti (per lungo tempo in linea con la produttività); gli standard di vita sono migliorati e le diseguaglianze per lungo tempo sono state tenute sotto controllo dallo sviluppo dei sistemi di Welfare e dalla contrattazione collettiva. Di conseguenza, l’immiserimento crescente dei lavoratori non si è verificato e il «crollo del capitalismo» per questa via è uscito dall’orizzonte politico, oltre a perdersi come categoria analitica.
Sarebbe una forzatura agganciare al conflitto che si è svolto sul terreno politico istituzionale il dibattito, che pure ha impegnato tanto marxismo, sulla rivoluzione come processo e la rivoluzione come salto, sebbene sia stato usuale in una certa fase riferirsi alla via democratica al socialismo.
Altri fattori allontanano dalle previsioni di Marx e riguardano l’arti- colazione sociale che si è andata configurando. Allo sviluppo delle funzioni pubbliche dobbiamo la crescita di una schiera consistente di impiegati pubblici, e alla complessità crescente e all’articolazione della produzione l’espansione dei colletti bianchi anche nel settore privato. Il settore del piccolo commercio, dell’artigianato e della piccola imprenditoria è sopravvissuto e si è espanso con la crescita dei consumi, pur nella crescente concentrazione del capitale. In sostanza, è cresciuta enormemente la presenza dei ceti medi e della piccola borghesia nella popolazione, rendendo minoritaria la consistenza dei ceti operai anche nel momento della loro massima espansione. Per cui è cambiata la dinamica sociale (e di riflesso politica), sempre più lontana da quella rappresentazione dicotomica che ne aveva dato Marx.
Risiede forse anche in questa frammentazione della società il successo che ha avuto la controffensiva neoliberista, che di fatto ha teso a rovesciare i rapporti di forza e far indietreggiare il primato della politica, della scelta collettiva e della partecipazione. Una controffensiva, di fatto anticipata e legittimata da una costruzione culturale indirizzata a una critica della società che si era affermata, e che veniva rappresentata come eccessivamente burocratizzata e costosa per il contribuente, distorsiva del mercato del lavoro con danni all’occupazione, prona all’inflazione, priva di incentivi per l’eccesso di Welfare, inefficiente per la presenza dell’impresa pubblica (o, in generale, per la presenza pubblica dove avrebbero potuto agire i privati), per il controllo dei movimenti di capitale. Non è di questo che voglio parlare (chi vuole approfondire può rivolgersi al mio volume del 2016, Regole, Stato, uguaglianza). Dico solo che le conseguenze di quel successo hanno reso la classe dominante più sicura di sé (anche per aver piegato a sé la distribuzione del reddito e della ricchezza), l’hanno messa in condizioni di dissociare le proprie fortune da quelle della collettività, e messa in grado di catturare lo Stato costringendolo a scelte business friendly.
Il processo capitalistico che ne è risultato in parte riporta a Marx, alla forte adesione della cultura dominante a un quadro sociale forgiato dalla logica del mercato e del profitto, alla protezione estesa della proprietà mentre si allentano i diritti sociali, alla libertà di azione di cui godono le decisioni economiche dei privati, alla concentrazione incontrollata della ricchezza e della produzione. Ma, soprattutto, riporta alle crisi come caratteristica congenita del capitalismo, di cui l’ultima del 2008 – pur avvenuta con modalità diverse da quelle pensate da Marx – è la conferma che il capitalismo non può vivere senza generarle, ritrovandosi poi in un deserto sociale come quello prodotto dagli effetti del 2008, che si trascinano fino a oggi.
E la lotta di classe?
Ci si può chiedere che ne è allora della lotta di classe. Si sa che non è mai stata automatica la traduzione della condizione sociale in coscienza sociale, ma ora si è pure ristretto, se non dissolto, il nucleo che aveva avuto il ruolo politico di catalizzatore del conflitto e delle istanze popolari. Il proletariato industriale – ormai precarizzato, colpito dall’insicurezza che investe gli strati subalterni del corpo sociale, parcellizzato in situazioni differenziate, implicitamente ricattato e ridotto fortemente di numero – ha perso identità politica. La società frammentata odierna, che si apre a ventaglio in tanti articolati sociali disagiati o marginalizzati, che mancano di identità specifiche (tanto meno collettive), rende difficile parlare perfino di classe in sé (o classi in sé).
Ciononostante, risulta evidente che il capitalismo spacca la società tra chi è sopra e chi è sotto nella piramide sociale, chi vive il benessere e chi il disagio. Se la spacca socialmente deve in potenza poterla spaccare politicamente, nonostante tutti i meccanismi culturali, economici e tecnologici messi in atto perché ciò non avvenga. Portare assieme coloro che si trovino nelle medesime condizioni per cambiare assieme il proprio destino è un compito politico. Un compito che è mancato per ragioni che non tocco qui. La costruzione di coalizioni che lottino per l’eguaglianza è, di nuovo, un compito politico. Per quanto sia, le classi sociali continuano a esistere; facciamo parte di «una comunità di destino che subisce tutte le conseguenze di tale appartenenza, come la maggiore o minore possibilità di passare da una classe all’altra, di fruire di una quantità di risorse e beni immateriali, di disporre del potere di decidere il proprio destino e di poterlo scegliere», come ebbe a descrivere Luciano Gallino. Il restringimento delle possibilità materiali, della fiducia in un progresso inevitabile e il restringimento al vertice di quella piramide non possono non far riemergere l’antagonismo – se il capitalismo è nella sostanza quello descritto da Marx.
E, infatti, il capitalismo odierno deve fare i conti con un’importante novità rispetto al periodo della sua grande affermazione. Si è fortemente incrinata la sua legittimità presso larghe masse, che d’altra parte non sono mai state particolarmente attratte dalle sue narrazioni. La difficoltà della crescita e gli stenti dell’occupazione, nonché la crescente e abnorme divaricazione nella distribuzione del reddito e della ricchezza, rendono difficile agli strati subalterni l’accettazione degli esiti prodotti dai meccanismi economici e sociali. Implicitamente, quella che si è messa in moto è una dinamica di classe, o di classi subalterne, che si esprime, però, attraverso una contestazione per ora confusa. D’altra parte, Marx affidava alla perdita di legittimità la rottura del sistema, in quanto egli demandava il momento del salto qualitativo a quando i lavoratori si sarebbero accorti dell’antagonismo in cui si poneva la loro posizione sociale rispetto a quella della classe borghese. Dove porti oggi l’incrinatura della legittimità non è chiaro (e in ogni caso a questa ho dedicato il mio saggio in onore di Reichlin, di prossima pubblicazione su «Italianieuropei»).
Tuttavia, la lotta di classe esiste – eccome – se la interpretiamo in senso opposto a quello in cui la intendeva Marx, con protagoniste non le classi subalterne ma le forze dominanti. Non è che lotta di classe quella portata dalle classi dominanti per riacquistare il potere e i profitti che le erano stati sottratti. Quello che è sicuramente cambiato dai tempi di Marx è la quantità di risorse di cui questa classe ha disposto, l’estensione numerica, la proiezione e le connessioni internazionali. Non c’è bisogno di personificare questa controffensiva o pensarla come strategia elaborata in sedi di raduno dai rappresentanti di quella classe; è stata una reazione guidata da eventi favorevoli e da una logica intrinseca al capitalismo.
La finanza e i conti del marxismo con Keynes
L’altro elemento di novità nei connotati che è venuto assumendo il capitalismo è il dominio che vi esercita la finanza, o meglio, il divenire un sistema a trazione finanziaria. La finanza in quanto tale esisteva anche al tempo di Marx, ma quando egli morì il suo sviluppo come la intendiamo oggi era agli albori. Vi sono passi del Terzo Libro in cui però la tira in ballo come elemento costitutivo e accenna alla possibilità che la classe imprenditoriale, invece di accrescere il capitale produttivo (nella sua terminologia «accumulare plusvalore», ma eviterei il termine per ciò che ho detto in apertura sul valore-lavoro), lo impieghi finanziariamente. «Nella misura in cui avviene, la borghesia si allontana dall’attività produttiva e diventa sempre più, come ai suoi tempi la nobiltà, una classe che semplicemente intasca le rendite». Nella verità che esprime, quest’immagine non è completamente esatta perché oggi l’attività finanziaria non è proprio un rifugio passivo, ma è un’attività costantemente monitorata e densa di decisioni, anche repentine.
La lettura finanziaria del capitalismo ci porta a Keynes: questa riflessione su Marx e sull’inquadramento teorico di questo modo di produzione non sarebbe completa senza un confronto con Keynes e gli emendamenti che questo autore consente di incorporare in quella dottrina. Keynes, al pari di Marx, indaga le caratteristiche principali del capitalismo e le forze che in un determinato momento storico hanno influenza su produzione e occupazione. Come Marx, egli lo inquadra dal punto di vista della dinamica impressa dalle decisioni imprenditoriali. La principale differenza è che per Keynes – che scrive mezzo secolo dopo la morte di Marx – il capitalismo non è concepibile senza le istituzioni finanziarie; quel sistema è un sistema monetario di produzione. Le decisioni di spesa vanno connesse (almeno come condizione necessaria) alla liquidità che ciascun operatore può mobilitare attraverso il credito o di cui ciascuno può disporre (oltre che a condizioni generali che dipendono dai vincoli posti dalle autorità nella generazione di liquidità). Quelle decisioni quindi vanno viste simultaneamente dal punto di vista reale e finanziario. Ma percettori di reddito da lavoro e capitalisti si differenziano. Mentre le decisioni dei primi sono prevalentemente vincolate dalle entrate correnti, quelle dei capitalisti (di chi investe) in generale non lo sono: la spesa relativa (destinata all’accumulazione) non è limitata dai profitti e dalle disponibilità correnti ed è finanziata con indebitamento. Tuttavia, le decisioni che la determinano sono prese in condizioni di incertezza sul futuro e, di conseguenza, le mutevoli opinioni sul futuro influenzano i livelli di produzione e occupazione corrente. Lo scopo è ovviamente quello di incrementare i profitti, per cui le si può mettere dentro uno schema di M-D-M di marxiana memoria. La visione dinamica del capitalismo che ha Keynes è sviluppata con la stessa metodologia sequenziale che avevo indicato come prezioso insegnamento analitico di Marx. È determinata da spinte e controspinte dentro le forze predominanti tracciate nel capitalismo finanziario dalla logica del profitto.
Se guardiamo il processo da un punto di vista reale, la considerazione prima è che le decisioni di domanda e quelle di offerta (produzione) sono indipendenti le une dalle altre, per cui vi può essere equilibrio se si rispettano alcuni rapporti intersettoriali, ma questo è un caso, esattamente come negli schemi di riproduzione di Marx. (E, infatti, partendo da quegli schemi, un economista marxista, Kalecki, anticipa alcune conclusioni della teoria keynesiana.) Per Keynes il mercato non è meno anarchico che per Marx: non si autoequilibra, l’offerta non genera la domanda equivalente (Keynes rifiuta come Marx la legge di Say): il capitalismo quindi genera instabilità e può trovare equilibrio in condizioni di sottoccupazione.
Se guardiamo il processo da un punto di vista finanziario, la considerazione prima è che il sistema si regge su debiti e crediti, per cui la convalida degli investimenti si ha quando il denaro investito rifluisce nell’impresa attraverso i profitti e consente di pagare i debiti. Ovviamente, tanto più il sistema si espande, tanto più è probabile che questo avvenga per la generalità delle imprese. Ma, se non è così, il debito va rifinanziato – finché si può – con nuovo debito; oppure comporta perdite che coinvolgono il valore del credito.
Nell’ottica finanziaria, il sistema va considerato anche dal punto di vista di chi ha la titolarità del credito, in quanto la contropartita dei debitori sono, appunto, i creditori. Per essi quel credito è ricchezza patrimoniale, che non è più direttamente detenuta in capitale reale ma in strumenti finanziari, gestiti, oltre che per conservare valore, per accrescere quella ricchezza o renderla redditizia (l’evoluzione che anche Marx intravede). Solo che nelle moderne economie quella ricchezza e i frutti che genera sono intermediati dalle banche o da altri soggetti finanziari, i quali sono anche i titolari del credito verso le imprese; la borsa è ormai parte integrante del processo capitalistico. In più, la finanza acquista una veste autonoma rispetto alla produzione, in una serie di scommesse che creano piramidi finanziarie che hanno la tendenza endogena a scalare per dimensione e rischio. Il sistema lasciato a sé stesso è soggetto a mettere a repentaglio, attraverso crisi ricorrenti, tutto quanto assieme: produzione, ricchezza e solidità degli intermediari coinvolti. Non sono più le crisi previste da Marx (hanno ormai natura prevalentemente finanziaria), ma sono comunque crisi endogene alla dinamica e alla logica del capitalismo. E sono molto più probabili quando questo finisce per incorporare – come è endogenamente portato a fare – prevalenti condizioni di «Ponzi finance», come le descrive Minsky (un economista keynesiano, ma anche di formazione marxiana e schumpeteriana), che si verificano in quegli scenari in cui i debitori non sono in condizioni di ripagare il prestito e gli interessi connessi, ma contano per farlo su guadagni in conto capitale (in pratica, l’origine della crisi del 2008).
Keynes vive quando lo Stato moderno si è già formato e può assegnare a quest’ultimo il compito di stabilizzazione, di intervento diretto, oltre che la responsabilità negli assetti macroeconomici e sociali. Parla a un certo punto di necessità di «socializzazione dell’investimento» per tenere la piena occupazione. Non è un caso che il bersaglio culturale della rivoluzione neoliberale sia la sua opera, non quella di Marx.
Finché la visione keynesiana ha retto l’economia, possiamo ritenere con Minsky che lo stesso livello aggregato dei profitti si sia trasformato in una variabile sociale, cioè a responsabilità sociale. Gli intrecci finanziari di cui sopra sono stati il motivo, avverte lo stesso grande keynesiano, per cui le banche centrali si sono preoccupate di salvaguardare la solidità del sistema dal punto di vista della solvibilità e dei prezzi, preoccupandosi anzitutto che i profitti aggregati non cadessero, prima ancora di preoccuparsi dell’occupazione.
Minsky è morto nel 1986 e non ha potuto assistere al ritorno dei profitti come variabile – mettiamola così – autodeterminata, che si è protetta da sola, non ha accettato limitazioni e ha scalato in entità e porzione del reddito, parallelamente – e questo è il paradosso – all’indebolimento della solvibilità del sistema.
Conclusioni
La mia è una descrizione per sommi capi volta a dare ragione di come siano cambiati i connotati del capitalismo, anche se non ne sono cambiate la natura e le logiche. Ma, per capire il volto della società, è ancora una seria analisi di classe che deve guidarci e il rapporto con la riproduzione del sistema. Marx ci dice poco dal punto di vista predittivo, ma fissa le categorie analitiche e metodologiche con le quali muoverci. Non il valore-lavoro, ma un approccio fondato sulla storia, l’analisi politica, il conflitto di interessi, la soggettività, le condizioni materiali. Un approccio che va a cercare le logiche interne dei processi.
Riconosciuto il debito che abbiamo nei confronti del Marx scienziato sociale, possiamo anche riconoscere che i conflitti non si esauriscono in quelli economici, e che la società è percorsa anche da altri conflitti e identità (religiose, etniche, nazionali, di genere) che agiscono nei comportamenti e si rafforzano proprio quando si indeboliscono le identità sociali. Dobbiamo riconoscere anche che il rapporto fra struttura e sovrastruttura è meno rigido di come Marx l’ha presentato. Indubbiamente le idee non si formano fuori dalle condizioni oggettive della società; ma abbiamo anche imparato che nei mutamenti della storia la cornice scientifica e culturale, sebbene non venga dal nulla, ha effetti suoi propri, crea una narrazione che interagisce con quei mutamenti e li legittima, diventando a sua volta ispiratrice di perseguimenti e di proposte che muovono la società. Ma abbiamo veramente imparato quanto sia importante la cornice culturale? I liberisti risponderebbero, a ragione, di sì. Per altri (a giudicare dal disinvestimento culturale della sinistra politica) ho dei dubbi.
Per dare quei grandi frutti intellettuali che può dare, Marx deve essere letto «bene». Anche con un certo grado di indulgenza e molta capacità di discernimento (che temo vada acquisita fuori e prima del rapporto diretto con la sua opera, altrimenti troppo coinvolgente). Per il contenuto politico che ha avuto la sua analisi e per il riferimento dottrinario che ha costituito per i movimenti che a lui si sono ispirati (e, aggiungerei: per responsabilità di alcune appropriazioni accademiche) è stato spesso letto «male», non nel senso delle incomprensioni o del fraintendimento, ma dell’assenza di respiro, dell’inutile sosta in dispute infinite su questo o quel paragrafo, questa o quella citazione che lo hanno ossificato, ammantandolo di un’aura religiosa, e che hanno spesso ridotto l’insegnamento che se ne può trarre a una scolastica poco appassionante.
*Salvatore Biasco, già professore ordinario di Economia monetaria internazionale all’Università «La Sapienza» di Roma, è autore di numerose pubblicazioni in ambito economico e politico, ha vinto il premio Saint-Vincent per l’economia ed è stato parlamentare nella XIII Legislatura, tra i protagonisti del ridisegno del sistema fiscale. il Mulino 2/2019